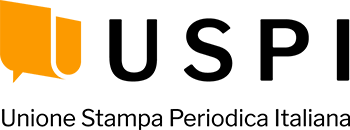Giovanni Falcone, Sebastiano Ardita, Nino Di Matteo e Nicola Gratteri: continuità e differenze contestuali sullo sfondo dell’unità della magistratura. Strumenti di comprensione e complessità dei temi giuridici nel dibattito pubblico
a cura di Mimma Cucinotta
Mentre il Parlamento italiano approva, il 30 ottobre 2025, la riforma sulla separazione delle carriere nella magistratura, il pensiero di Giovanni Falcone viene spesso richiamato nel dibattito pubblico, talvolta in modo non pienamente coerente con le sue posizioni originarie , in particolare, a un modello istituzionale che egli aveva chiaramente rifiutato.
Falcone parlava di funzioni, di responsabilità e di unità dell’ordine giudiziario, non di carriere separate.
Una distinzione fondamentale che rischia di andare perduta nella retorica politica odierna.
Il riferimento al suo nome è divenuto ricorrente soprattutto a partire dal 2024, con la presentazione della riforma costituzionale diretta a istituire due Consigli Superiori della Magistratura distinti e percorsi professionali separati per giudici e pubblici ministeri. Tale richiamo si è progressivamente esteso anche all’opinione pubblica, spesso influenzata dalla rappresentazione mediatica piuttosto che da una conoscenza approfondita e diretta del pensiero e dell’esperienza del magistrato.
Il pensiero di Falcone, quando utilizzato come argomento di legittimazione politica e sottoposto a una serie di interpretazioni, merita certamente una valutazione giuridica e filologica. Come osservato due anni fa nell’editoriale del magistrato Armando Spataro pubblicato su La Magistratura (n. 2/2023), tali distorsioni producono un “capovolgimento semantico del pensiero falconiano”, riducendolo a uno slogan funzionale a riforme che ne tradiscono la ratio originaria.
Nel contesto che cerchiamo di presentare, fondamentale appare ricordare la figura di Giovanni Falcone. Nato a Palermo il 18 maggio 1939, tra i più grandi magistrati italiani del Novecento, rappresenta una delle personalità più alte della storia repubblicana. Il suo nome è indissolubilmente legato alla lotta contro Cosa Nostra, alla costruzione di un metodo d’indagine innovativo e al senso profondo della giustizia. La sua morte, avvenuta il 23 maggio 1992 nella Strage di Capaci (Palermo) insieme alla moglie Francesca Morvillo, anche magistrato, e agli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, segnò profondamente la storia del Paese. Quell’attentato, così impietosamente orchestrato, tentò di spegnere una visione della giustizia fondata sulla competenza, sulla responsabilità e sull’indipendenza.
Falcone concepiva la magistratura come un’istituzione di servizio e non come una corporazione chiusa. In una delle sue ultime interviste, rilasciata a Micromega nel 1991, dichiarava che “la magistratura non deve essere una casta, ma una funzione dello Stato al servizio dei cittadini”. La sua osservazione era radicata nell’articolo 104 della Costituzione, dove l’unità dell’ordine giudiziario è garanzia e non minaccia per l’equilibrio democratico. Difendere questa unità significava garantire al giudice e al pubblico ministero la possibilità di operare senza condizionamenti esterni, politici o amministrativi.
Nel dialogo con Paolo Flores d’Arcais, pubblicato sul numero 2 del 1991 di Micromega, Falcone fu esplicito nel rifiutare la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. “Non credo che la separazione delle carriere sia la soluzione ai problemi della giustizia” affermò. “La vera riforma è nel rendere più responsabili i magistrati, non nel metterli sotto il controllo di altri poteri”. Nella stessa occasione denunciava come falsa la contrapposizione tra efficienza e indipendenza, convinto che la prima dovesse derivare da un’organizzazione razionale e da una cultura professionale rigorosa, non da una trasformazione ordinamentale.
Queste dichiarazioni testimoniano nettamente la coerenza di un pensiero che non può essere frainteso senza stravolgerne la logica. Falcone non difendeva privilegi corporativi né si opponeva al cambiamento, ma temeva che la separazione delle carriere potesse tradursi in una subordinazione del pubblico ministero all’esecutivo o in un controllo politico della giustizia. La sua idea era semplice e radicale: rafforzare la magistratura attraverso competenza e responsabilità, non attraverso la divisione.
Nel libro Cose di Cosa Nostra, pubblicato nel 1991 con la giornalista francese Marcelle Padovani, Falcone approfondì ulteriormente questo pensiero, tracciando un ritratto della giustizia come strumento di libertà sociale. “È fondamentale che la magistratura sia libera da ogni condizionamento, perché solo così può garantire la libertà di tutti. L’indipendenza del giudice e del pubblico ministero è un bene indivisibile”, scriveva. E ancora: “Chi invoca riforme per cambiare le carriere spesso nasconde il desiderio di controllare l’azione della giustizia. Il vero problema è la serietà e la preparazione dei magistrati“. La sua prospettiva era quella di un magistrato che conosceva dall’interno le fragilità del sistema, ma che rifiutava di risolverle con scorciatoie istituzionali.
Le sue proposte di riforma miravano a un’organizzazione più efficiente e meritocratica, alla creazione di una Direzione Nazionale Antimafia e di strutture investigative coordinate, non alla frammentazione del potere giudiziario. L’idea di un pubblico ministero “separato” gli appariva come una minaccia, non come una conquista. Per Falcone, la distinzione dei ruoli era doverosa, ma l’appartenenza comune allo stesso ordine giudiziario costituiva una garanzia democratica. Separare le carriere avrebbe significato introdurre una gerarchia esterna e, di conseguenza, la politicizzazione dell’azione penale.
Dopo la sua morte, il pensiero di Falcone continua ad essere oggetto di numerose torsioni interpretative. Alcune letture estrapolano le sue parole sul merito e sulla responsabilità nel sostegno alla tesi della separazione delle carriere, come se Falcone avesse auspicato una magistratura gerarchicamente distinta e doppia nei suoi organi di autogoverno. Nulla di più lontano dal suo pensiero.
Le sue dichiarazioni, lette nel contesto storico in cui furono pronunciate, rivelano un magistrato profondamente fedele alla Costituzione, convinto che la libertà del giudice e quella del pubblico ministero fossero elementi inseparabili di uno stesso disegno democratico.

Nel dibattito attuale sulla separazione delle carriere si inserisce con autorevolezza Sebastiano Ardita, attualmente procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania. Entrato in magistratura nel 1991, ha maturato una lunga esperienza in ambito antimafia come componente della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e successivamente come direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con la responsabilità dell’Ufficio detenuti e dell’attuazione del regime speciale 41‑bis. Ha inoltre ricoperto la carica di consigliere togato al Consiglio Superiore della Magistratura, contribuendo alle riflessioni istituzionali sulle riforme della magistratura e sulla posizione del pubblico ministero, e ha collaborato come consulente con la Commissione Parlamentare Antimafia nella redazione di documenti di indagine sulle attività criminali nella provincia di Catania. Autore di numerosi saggi, tra cui Ricatto allo Stato,(Sperling & Kupfer 2011), Catania bene (Mondadori 2015), Cosa Nostra S.p.A (PaperFirst 2020).
Ardita ha più volte espresso la sua contrarietà alla separazione delle carriere, sostenendo che la subordinazione del pubblico ministero al potere politico comprometterebbe l’indipendenza e l’efficacia della magistratura nella lotta alla criminalità organizzata.

Nel suo libro Al di sopra della legge – Come la mafia comanda dal carcere (Solferino 2022) il magistrato richiama lo Stato a una giustizia davvero impermeabile sottolineando come l’unità della giurisdizione rappresenti un presidio di libertà e una difesa dall’assoggettamento della giustizia alla politica. Ardita ritiene che la riforma, se applicata senza adeguate garanzie, possa minare la capacità della magistratura di resistere alle pressioni del potere, riducendo l’efficacia dell’azione penale soprattutto nei territori in cui lo Stato deve mantenere la propria solidità.
Pur operando in contesti storici profondamente differenti, Sebastiano Ardita si colloca in continuità sostanziale con l’impostazione di Giovanni Falcone in materia di assetto ordinamentale della magistratura e, in particolare, sul tema della separazione delle carriere tra magistratura requirente e magistratura giudicante.
Ribadendo questo principio, Ardita ha dichiarato:
“È un errore colossale pensare che separare le carriere possa rendere il pubblico ministero più rispondente alle esigenze della collettività… Un pubblico ministero sganciato dalla giurisdizione rischierebbe di rispondere a logiche di polizia.”
“Tra tutte queste riforme, la peggiore è la separazione delle carriere… sarebbe peggio ancora di una dipendenza diretta dall’esecutivo.”
“La separazione delle carriere è un grande fiocco su uno scatolo vuoto… perché allontana il pubblico ministero dalla cultura della giurisdizione.”
Secondo Ardita, la priorità non sarebbe separare le carriere, ma rafforzare l’autogoverno della magistratura, garantendo trasparenza, responsabilità e meritocrazia. Così come Falcone, egli difende un modello di magistratura unitario e indipendente, opponendosi a riforme che possano compromettere il corretto equilibrio tra i poteri dello Stato.
Sulla stessa linea si collocano Nino Di Matteo e Nicola Gratteri.

Antonino “Nino” Di Matteo, attualmente sostituto procuratore nazionale antimafia presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) e sotto scorta dal 1993, rappresenta uno dei magistrati italiani più impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Ha ricoperto il ruolo di membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura (2019‑2023) e quello di presidente della sezione distrettuale di Palermo dell’Associazione Nazionale Magistrati (2012‑2025), promuovendo trasparenza e indipendenza giudiziaria. Dal 1999 ha esercitato le funzioni di pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Palermo, seguendo indagini di grande rilievo, tra cui le stragi del 1992 e la Trattativa Stato‑Mafia, dopo aver iniziato la carriera nel 1991 come sostituto procuratore presso la sezione “Antimafia” della Procura di Caltanissetta. Nelle sue analisi e dichiarazioni, Di Matteo ha più volte sottolineato che separare le carriere rischia di trasformare il pubblico ministero in un mero funzionario del governo, richiamando costantemente l’insegnamento di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, secondo cui l’indipendenza del magistrato è condizione essenziale per l’equilibrio democratico e per la tutela della legalità.

In interviste e libri come I nemici della giustizia ( Rizzoli 2021), intervistato da Saverio Lodato, Nino Di Matteo conduce un’analisi critica e approfondita delle molteplici degenerazioni del sistema giudiziario italiano, esaminando con chiarezza il complesso rapporto tra magistratura e potere e interrogandosi sulla possibilità di recuperare la fiducia dei cittadini nell’operato della magistratura. Una riforma che riduca questa autonomia, sostiene, rischia di trasformare la giustizia penale in uno strumento del potere politico.

Analogamente, Nicola Gratteri, attualmente procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nonché ex sostituto procuratore alla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catanzaro. Sotto scorta dal 1989 ha maturato una lunga esperienza nel contrasto alla n”drangheta e alle sue ramificazioni nazionali e internazionali, con particolare attenzione alle connessioni tra criminalità organizzata, politica e affari economici.

Autore di numerosi volumi insieme ad Antonio Nicaso, tra cui Cartelli di sangue. Le rotte del narcotraffico e le crisi che lo alimentano (Mondadori, 2025), adotta un approccio pragmatico ma sostanzialmente convergente con la visione dell’indipendenza del pubblico ministero. Pur riconoscendo la necessità di regole più chiare e di maggiore trasparenza, Gratteri ribadisce che la separazione delle carriere non deve mai tradursi in subordinazione del magistrato al potere politico, convinto che l’autonomia del magistrato costituisca una condizione minima per colpire efficacemente la criminalità organizzata e le sue connessioni con il potere economico e politico.
Le convergenze di pensiero tra Falcone, Ardita, Di Matteo e Gratteri sono chiare. Tutti pongono come condizione non negoziabile l’autonomia del pubblico ministero rispetto all’esecutivo. Per Falcone questo era un principio costituzionale e morale; per Ardita, una garanzia contro la politicizzazione della giustizia; per Di Matteo e Gratteri, un elemento vitale per la sopravvivenza stessa dell’azione antimafia. L’esperienza diretta di chi ha vissuto le inchieste sulle stragi e sulla criminalità organizzata rende questa posizione tutt’altro che teorica maturata sul campo, nei processi più complessi e sotto la pressione di poteri forti.
Nel dibattito pubblico attuale, spesso dominato da slogan o semplificazioni, si tende a presentare la separazione delle carriere come moderno baluardo della giustizia. Ma dietro le parole, ammoniscono questi magistrati, si nascondono conseguenze che non sempre vengono comprese. Un pubblico ministero meno indipendente, più esposto a influenze esterne e più lontano dai giudici, rischia di diventare un soggetto meno libero di indagare anche sui vertici dello Stato. La preoccupazione è che un intervento nato per chiarire i ruoli finisca per alterare gli equilibri democratici e ridurre gli spazi di libertà.
Falcone aveva previsto questo rischio con lucidità, ricordando che l’azione penale deve restare indipendente per evitare che la giustizia diventi strumento di potere. Le riflessioni di Ardita, Di Matteo e Gratteri proseguono su questa linea. Ben consapevoli per esperienza diretta, quanto sia sottile la frontiera che separa un magistrato libero da uno condizionato. Per questo insistono sul fatto che ogni riforma, anche animata da buone intenzioni, deve essere accompagnata da garanzie solide, trasparenti e verificabili.
A conferma di queste preoccupazioni, anche osservatori e organismi internazionali recenti sottolineano la centralità dell’indipendenza dei magistrati e dei pubblici ministeri. Gli ELI‑Mount Scopus European Standards of Judicial Independence (2024) ricordano che nomina, promozione e disciplina dei magistrati devono avvenire secondo criteri trasparenti e imparziali, affinché l’azione penale e giudiziaria non risulti subordinata a influenze esterne. Analogamente, il rapporto annuale 2024 dell’Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale evidenzia che l’azione penale indipendente è condizione essenziale per la tutela dei diritti fondamentali e per la credibilità dello Stato di diritto.
Il Consultative Council of European Prosecutors e la OECD ribadiscono che ogni riforma organizzativa non deve ridurre l’autonomia del pubblico ministero, e che la trasparenza, la responsabilità e la meritocrazia devono guidare le scelte sul governo della magistratura.
In questo quadro, le preoccupazioni espresse da Falcone e dai magistrati italiani contemporanei non sono isolate né meramente nazionali. Esse riflettono una tendenza unanime a livello internazionale: la libertà del pubblico ministero e l’unità dell’ordine giudiziario sono elementi imprescindibili per prevenire l’uso della giustizia come strumento di potere, garantire processi equi e mantenere la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto.
L’integrazione delle esperienze e delle raccomandazioni internazionali rafforza così la linea ideale e pratica tracciata da Falcone, ribadita da Ardita, Di Matteo e Gratteri: ogni riforma ordinamentale deve essere concepita non come fine a se stessa, ma come strumento per consolidare l’indipendenza, la trasparenza e la responsabilità della magistratura, assicurando che il pubblico ministero rimanga libero e capace di perseguire la giustizia anche nei casi più delicati.
La questione fin qui esposta riveste certamente carattere squisitamente giuridico e, in quanto tale, non facilmente accessibile nei suoi contenuti più complessi alla generalità dell’opinione pubblica. In assenza di conoscenze giuridiche adeguate, l’elaborazione di un giudizio informato potrebbe essere condizionata da letture semplificatrici o da strumentalizzazioni, che finirebbero per alterare il senso del dibattito e ridurne la comprensione.
Le conseguenze di tale processo sono significative, poiché incidono sul livello di consapevolezza dei cittadini e sulla loro capacità di valutare con equilibrio le implicazioni di una riforma, in particolare in rapporto all’autonomia e all’indipendenza della magistratura. Anche il richiamo a Giovanni Falcone evidenzia modalità parziali o distorte, attraverso un processo di reinterpretazione che, seppur sottile, rischia di travisare la centralità del suo pensiero.
Tale fenomeno, di natura prevalentemente ideologica, sembra insinuarsi in modo quasi impercettibile nel dibattito pubblico, fino a influenzare anche chi, pur possedendo competenze giuridiche, non riesce a mantenere un sufficiente distacco critico. In questa prospettiva, la strumentalizzazione del pensiero di Falcone e, più in generale, della riflessione sulla separazione delle carriere, potrebbe rappresentare non soltanto un limite alla corretta informazione dei cittadini, ma anche un impoverimento del confronto giuridico, che dovrebbe invece fondarsi su rigore analitico, consapevolezza storica e rispetto delle fonti.
Alla luce di quanto esposto, emerge con chiarezza come la tutela dell’indipendenza del pubblico ministero e dell’unità dell’ordine giudiziario non sia una questione puramente tecnica o interna, ma un principio fondamentale la cui corretta comprensione richiede attenzione, competenza e senso critico. Il dibattito pubblico, pur essendo inevitabilmente complesso, non può prescindere da questi elementi se si vuole evitare che riforme potenzialmente meritorie si trasformino in strumenti di condizionamento o di indebolimento della giustizia stessa. @Riproduzione Riservata
……