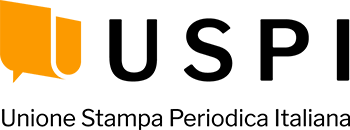Storia, arte e politica convivono nei palazzi del potere della capitale: splendidi, monumentali edifici a poca distanza l’uno dall’altro che raccontano la storia politica e sociale non solo dell’Urbe ma spesso dell’Italia intera: sono Montecitorio, Palazzo Chigi, Palazzo Madama e il Quirinale. Iniziamo il nostro tour alla scoperta di Palazzo Montecitorio .
All’indomani dell’Unità d’Italia, si pose il problema della scelta delle nuove sedi istituzionali, condizionata sia da fattori politici di consolidamento del potere, sia da fattori economici, che facevano propendere per soluzioni di riuso e riadattamento di antiche sedi possibilmente di consolidata autorità simbolica. Come già accaduto per Torino e Firenze, quando la capitale fu trasferita a Roma, venne istituita una commissione per la selezione dei palazzi da destinare a sedi del nuovo Governo, che ben presto individuò quelli da riadattare all’uso che si rendeva necessario, vista la quantità di splendidi palazzi nobiliari che la città metteva a disposizione. Iniziamo il nostro viaggio fra palazzi del potere dalla sede della Camera dei Deputati e sede del Parlamento riunito in seduta comune: palazzo Montecitorio, la cui storia inizia alla metà del XVII sec., quando papa Innocenzo X commissiona la costruzione del palazzo nobiliare per la famiglia Ludovisi, con cui era imparentato, a quello che potremmo definire l’archistar del tempo, Gian Lorenzo Bernini. Il palazzo prende il nome dall’altura dove viene eretto al posto di casupole preesistenti, il Monte Citorio, la cui origine incerta si fa risalire al fatto che nell’antichità fosse il luogo delle assemblee elettorali romane, “mons citatorius” (da citare, chiamare) o piuttosto al fatto che si fosse formata dall’accumulo dei materiali di scarto derivanti dalla bonifica del campo Marzio, “mons acceptorius”. Il Bernini adattò il suo progetto all’assetto urbanistico preesistente, realizzando una facciata che segue l’andamento curvilineo del luogo con i corpi laterali leggermente arretrati rispetto a quello centrale, secondo un gusto scenografico squisitamente barocco. Dopo pochi anni, a causa della morte del pontefice seguita da quella del Bernini, nonché della mancanza di fondi, i lavori subirono uno stop e vennero ripresi soltanto venti anni dopo da papa Innocenzo XIII con l’iniziale intenzione di destinare il palazzo a ospizio per i poveri e successivamente di installarvi i tribunali pontifici, la cosiddetta Cura Innocenziana. I lavori vennero affidati ad un altro illustre architetto, Carlo Fontana, che pur modificando completamente il progetto berniniano, ne conservò la caratteristica facciata convessa, ma con l’apertura delle due porte ai lati dell’ingresso principale e l’aggiunta del campanile a vela, la cui campana maggiore, un tempo segnale dell’inizio delle udienze, oggi suona solo in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica.

Palazzo Montecitorio, Roma
Palazzo Montecitorio è stato successivamente anche sede del Governatorato di Roma e della direzione di polizia, divenendo il centro della vita amministrativa e giudiziaria del governo pontificio. Quando, dopo l’Unità d’Italia, la scelta per la sede della Camera dei deputati è caduta su Montecitorio, sono stati avviati con grande rapidità i lavori di adattamento del vecchio palazzo alle nuove esigenze, affidando il compito all’ingegnere dei lavori pubblici, Paolo Comotto, che edifica nel grande cortile una sala semicircolare a gradinate su un’intelaiatura di ferro interamente ricoperta di legno destinata a sede dell’aula assembleare. Inizialmente lodata anche perché alterava il meno possibile il preesistente, la nuova aula si è dimostrata presto acusticamente e termicamente inadeguata in quanto caldissima d’estate e freddissima d’inverno, al punto che i deputati erano autorizzati dal presidente, nelle giornate particolarmente rigide, a tenere in testa il cappello. Nel 1900 l’aula viene dichiarata inagibile e chiusa dai Questori della Camera che traferiscono i lavori in un’auletta provvisoria mentre il Governo aveva affidato lavori di ampliamento ad Ernesto Basile. Il famoso architetto liberty decide di conservare il corpo di fabbrica seicentesco della Curia Innocenziana con la sua facciata su piazza Montecitorio, ma annettendovi un nuovo edificio di ampliamento per rispondere alle mutate esigenze funzionali. Il nuovo palazzo, un grosso edificio di travertino e di mattoni rossi, di forma quadrata e con quattro torrioni medievaleggianti, richiede profonde trasformazioni urbanistiche, con lo sventramento del tessuto preesistente, la creazione di due strade parallele al nuovo edificio e di una nuova piazza, per sottolinearne l’ingresso alle spalle del vecchio, secondo la logica dello sventramento, che caratterizzò in quegli anni gli interventi nelle grandi capitali europee.
 All’interno di questo edificio, Basile colloca la nuova aula delle sedute, coperta dal celeberrimo velario realizzato da Giovanni Beltrami, uno straordinario lucernario a ventaglio in stile liberty, e il cosiddetto “Transatlantico”, poiché arredato nello stile tipico delle grandi navi d’inizio secolo, una sorta di lungo corridoio in cui deputati e giornalisti sostano durante le pause delle sedute. Il Palazzo è anche lo scrigno di una vasta collezione d’arte, composta da oltre mille dipinti e sculture datati tra il XVI e XX secolo, alcune migliaia di incisioni e stampe di varie epoche, un numero consistente di reperti archeologici oltre a orologi, arredi, arazzi e busti, che si è formata fin dall’insediamento della Camera con molteplici modalità: una parte infatti, di proprietà di diverse Soprintendenze, è in deposito temporaneo; un’altra parte è stata direttamente acquistata a partire dagli anni Cinquanta e una piccola parte, infine, è stata oggetto di donazione da parte degli artisti o dei loro eredi. È notizia recente il “ritrovamento” della cosiddetta Gioconda della Camera, una copia opera della scuola di Leonardo della quale per circa un secolo si erano perse le tracce, riscoperta in maniera fortuita appesa sopra il termosifone della stanza di uno dei questori di Montecitorio. Secondo alcuni studiosi lo stesso maestro potrebbe aver messo mano all’opera, in base a documenti che ipotizzano che, come in uso all’epoca, siano state realizzate più versioni dello stesso dipinto. Il tempo ci svelerà il mistero, nel frattempo, proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei palazzi del potere a Roma.
All’interno di questo edificio, Basile colloca la nuova aula delle sedute, coperta dal celeberrimo velario realizzato da Giovanni Beltrami, uno straordinario lucernario a ventaglio in stile liberty, e il cosiddetto “Transatlantico”, poiché arredato nello stile tipico delle grandi navi d’inizio secolo, una sorta di lungo corridoio in cui deputati e giornalisti sostano durante le pause delle sedute. Il Palazzo è anche lo scrigno di una vasta collezione d’arte, composta da oltre mille dipinti e sculture datati tra il XVI e XX secolo, alcune migliaia di incisioni e stampe di varie epoche, un numero consistente di reperti archeologici oltre a orologi, arredi, arazzi e busti, che si è formata fin dall’insediamento della Camera con molteplici modalità: una parte infatti, di proprietà di diverse Soprintendenze, è in deposito temporaneo; un’altra parte è stata direttamente acquistata a partire dagli anni Cinquanta e una piccola parte, infine, è stata oggetto di donazione da parte degli artisti o dei loro eredi. È notizia recente il “ritrovamento” della cosiddetta Gioconda della Camera, una copia opera della scuola di Leonardo della quale per circa un secolo si erano perse le tracce, riscoperta in maniera fortuita appesa sopra il termosifone della stanza di uno dei questori di Montecitorio. Secondo alcuni studiosi lo stesso maestro potrebbe aver messo mano all’opera, in base a documenti che ipotizzano che, come in uso all’epoca, siano state realizzate più versioni dello stesso dipinto. Il tempo ci svelerà il mistero, nel frattempo, proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei palazzi del potere a Roma.