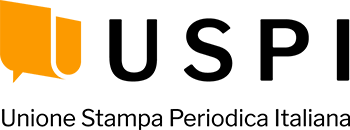“Per combattere il male peggiore, ci si affidò a quello minore. Il problema è che, dopo, il male minore restò. E cominciò a comandare.”
di Massimo Reina, per Giornalisti Senza Frontiere
C’è una storia che non troverete nei libri di testo scolastici. Una storia che non nega la Liberazione, non disonora i soldati alleati, né i partigiani, né i cittadini italiani che hanno pagato con la vita. Ma una storia che – se davvero siamo una democrazia matura – va raccontata. Anche se sporca. Anche se fa male.
È la storia dell’Operazione Underworld, della collaborazione tra governo USA e mafia americana durante la Seconda Guerra Mondiale, e della sua evoluzione.
Una collaborazione non scritta che, col tempo, si allargò anche all’Italia. In particolare alla Sicilia, diventata pedina strategica durante l’Operazione Husky, il famoso sbarco angloamericano del 1943 dove Cosa Nostra non aiutò gli Alleati ad approdare sulle spiagge dell’isola, ma fornì appoggi locali utili per stabilizzare e “pacificare” l’isola dopo la caduta del regime.
Luciano, il patriota. O forse no.
Il protagonista ha un nome da gangster hollywoodiano: Lucky Luciano. Il re di Cosa Nostra newyorkese, boss della famiglia Genovese,all’epoca in galera per sfruttamento della prostituzione. Ma anche uno che – secondo fonti ufficiali dell’OSS, l’Office of Strategic Services (antenato della CIA) – poteva garantire l’ordine nei porti americani, dove il governo temeva sabotaggi dai simpatizzanti nazisti o da qualche temerario U-boot.
In tal senso, la U.S. Navy, allarmata dopo l’incendio della nave Normandie nel porto di New York nel febbraio del 1942 – avvenuto probabilmente per negligenza durante i lavori di conversione a imbarcazione da guerra, ma scambiato per un atto doloso – chiese aiuto ad Albert Anastasia e Meyer Lansky, che si fecero quindi intermediari tra mafia e governo (U.S. National Archives – Navy Records – Office of Naval Intelligence (ONI) reports)). I vertici della Marina ottennero così che Joseph “Socks” Lanza, legato a Lucky Luciano, usasse la sua influenza sul sindacato dei pescatori e dei portuali.
Tim Newark, nel suo documentatissimo “Mafia Allies: The True Story of America’s Secret Alliance with the Mob in World War II” (2010), spiega che fu proprio grazie a Charles “Lucky” Luciano se i moli di New York e i lavoratori portuali rimasero “tranquilli” e collaborativi. In cambio, Luciano ottenne la scarcerazione anticipata e, soprattutto, l’esilio in Italia nel 1946. Patria d’origine. E paradiso mafioso.
Sicilia, la chiave. E il patto col diavolo.
Secondo lo storico Salvatore Lupo, uno dei massimi esperti di storia della mafia, non ci fu mai un “patto scritto” tra OSS e mafia siciliana. Ma esistono numerose evidenze che dimostrano una convergenza di interessi.
Lo stesso Newark spiega che, quando l’Operazione Husky fu lanciata (10 luglio 1943), gli alleati avevano bisogno di tre cose: strade sicure, popolazione non ostile, canali di informazione sul territorio. Chi meglio della mafia locale poteva offrirli, conosceva i percorsi di montagna, i sentieri, i capi villaggio e i “silenzi” giusti da pagare?
Calogero Vizzini, boss di Villalba e amico di fiducia di Lucky Luciano, noto anche come “don Calò”, fu messo a capo della polizia locale nel dopoguerra dagli stessi americani. Lo irportano documenti d’epoca e perfino John Dickie nel su “Cosa Nostra. Storia della mafia siciliana”. Come se Al Capone fosse stato nominato sindaco di Chicago. Giuseppe Genco Russo, altro uomo di fiducia del potente boss della famiglia Genovese, divenne sindaco di Mussomeli.
Il rapporto segreto dell’OSS (Office of Strategic Services), desecretato negli anni ’70 e riportato in parte nel volume “The Mafia and the Allies” di Charles H. Brower, parla chiaro: “Don Calò fu utile nel garantire la stabilità a Villalba e nel mantenere l’ordine”. Documenti relativi all’amministrazione alleata in Sicilia (AMGOT) e alla riorganizzazione dei municipi siciliani nel ’43–’44 confermano che diversi mafiosi furono nominati sindaci o incaricati nei Comitati di Liberazione.
Ma fu utile solo quello? O fu anche un uomo di fiducia per assicurarsi che l’occupazione fosse digerita dalla popolazione locale, stremata da bombardamenti e miseria?
Il silenzio degli innocenti
Nessuno lo dice mai, ma l’occupazione alleata non fu un pic-nic per tutti. I rapporti dell’epoca – compresi alcuni cablogrammi interni dell’Allied Military Government of Occupied Territories (AMGOT) – parlano di saccheggi, stupri, esecuzioni sommarie, violenze. Non ovunque, certo. Ma abbastanza da alimentare rabbia, sfiducia, e nostalgia per il regime appena crollato. In molti paesi siciliani, la mafia fu la chiave per “sedare” questa rabbia, per gestire la fame, i bisogni, la paura.
Come scrive lo storico Alfio Caruso in “Arrivano i nostri” (Longanesi, 2003), l’alleanza con la mafia fu una scorciatoia, usata dagli americani anche per “evitare problemi inutili in un territorio sconosciuto e ostile”. Il risultato? La mafia, che il regime fascista aveva in parte ridotto con l’opera repressiva di Mori, tornò più forte, più protetta, e – soprattutto – più legittimata.
Diciamolo chiaro: nessuno vuole negare la gratitudine per chi ci ha liberati dal nazifascismo. Ma tra liberatori e santi c’è di mezzo l’oceano. Letteralmente. Gli eserciti agiscono per strategia, non per sentimentalismo. E quando la strategia prevede il controllo di un territorio in fretta e senza opposizione, il fine giustifica i mezzi. Anche quando i mezzi si chiamano Luciano, Russo, o “don Calò”.
POSTILLA FINALE: Chi scrive non mette in discussione la Liberazione, né disonora la memoria dei soldati alleati, dei partigiani, degli italiani che hanno perso la vita per la libertà. Questo articolo non è contro di loro. È contro le scorciatoie, le complicità, le ipocrisie.
Perché la verità, come la libertà, non si negozia.
Nemmeno con una lupara.