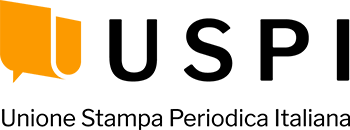Come Raqqa, come Mosul, come Aleppo, come ogni luogo in cui, dopo due giorni di titoli indignati, torniamo a occuparci di cose davvero urgenti, tipo il prossimo reality o il gol annullato alla nostra squadra.
In un Paese normale, i testamenti li scrivono i vecchi notai, con le mani che tremano e il timbro a secco. A Gaza, invece, li scrivono i ventottenni, senza carta bollata, ma con la certezza che ogni ora potrebbe essere l’ultima. Non per malattia, ma per una bomba. Non per un infarto, ma per un drone.
“Questo è il mio testamento. Se queste mie parole vi giungono, sappiate che Israele è riuscito a uccidermi e a mettere a tacere la mia voce“. Così scriveva Anas Al-Sharif, 28 anni, giornalista di Al Jazeera, mentre sapeva di avere il mirino puntato addosso. Non da un cecchino della mafia, non da un dittatore africano, ma da uno Stato che si definisce “l’unica democrazia del Medio Oriente” e che in Europa viene trattato come un vicino un po’ nervoso ma in fondo per bene.
E infatti l’hanno ucciso. Lui e altri quattro colleghi: Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa. Non in un covo di terroristi. Non mentre preparavano un attentato. No: in una tenda davanti a un ospedale. Perché in questa guerra la colpa non è in quello che fai, ma in quello che racconti.
Al-Sharif aveva scritto il suo messaggio a giugno, quando aveva già capito che non sarebbe arrivato a fine anno. Lo aveva pensato come una sorta di atto notarile per il mondo libero, quello che nelle pubblicità della NATO è sempre pronto a difendere la verità. Peccato che poi, quando la verità è scomoda, il mondo libero cambi canale.
“Ho profuso tutte le mie energie e le mie forze per essere un sostegno e una voce per il mio popolo… Nonostante ciò, non ho mai esitato a trasmettere la verità così com’è, senza falsificazioni o distorsioni. Che Dio sia testimone contro coloro che sono rimasti in silenzio… contro coloro che non hanno fermato il massacro”.
Il giornalista palestinese usa la parola massacro. Noi, nelle nostre redazioni patinate, preferiamo “operazione militare”, “azione di difesa”, “risposta armata”. Perché massacro è una parola che graffia, che disturba l’aperitivo.
“Vi affido la Palestina – prosegue –, il battito cardiaco di ogni persona libera in questo mondo… Vi prego di non essere ridotti al silenzio dalle restrizioni, né a essere paralizzati dai confini. Siate ponti verso la liberazione del Paese e del suo popolo”.
E qui casca l’asino — anzi, il mondo intero. Perché noi siamo già ridotti al silenzio. Non per colpa della censura (che sarebbe pure più dignitosa), ma per pigrizia, per noia, per quella tossica indifferenza che è diventata la religione ufficiale dell’Occidente.
La sua ultima preghiera è per la famiglia: “Vi affido la mia famiglia, la pupilla dei miei occhi… Vi affido la mia amata madre… Vi affido anche la mia compagna di una vita… Se dovessi morire, morirò saldo nei miei principi. Non dimenticate Gaza”.
Non dimenticate Gaza. Ma l’abbiamo già dimenticata. Dimenticata come Raqqa, come Mosul, come Aleppo. Come ogni luogo in cui, dopo due giorni di titoli indignati, torniamo a occuparci di cose davvero urgenti, tipo il prossimo reality o il gol annullato alla nostra squadra.
Nel testamento di un ragazzo di 28 anni c’è più dignità di quanta ne contenga un anno intero di discorsi dell’ONU. Ma noi, da bravi occidentali, continueremo a fare quello che sappiamo fare meglio: scorrere, cliccare, scrollare. Fino alla prossima strage da archiviare.