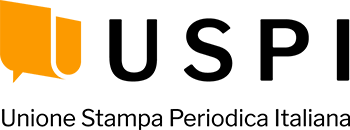Dalla formazione letteraria agli studi accademici fino al cinema, Christian Olcese si racconta in un’intervista intensa e sincera. In concorso alla XIV edizione del Catania Film Fest con La ragazza delle Gardenie, il giovane regista genovese porta sullo schermo un racconto che intreccia memoria, identità e poesia visiva.
Un dialogo sul valore della parola, sul rapporto tra cinema e letteratura, sul lavoro con gli attori e sul significato dei festival indipendenti come spazi di libertà creativa.
A cura di Maria Sole Stancampiano e Antonella La Mantia.
La ragazza delle gardenie è il titolo del cortometraggio del regista genovese Christian Olcese in concorso alla XIV edizione del Catania Film Fest, manifestazione in programma fino al 15 novembre presso il Centro Culturale Zo a Catania. Abbiamo intervistato Olcese che ci ha raccontato della sua esperienza e del legame strettissimo tra il mondo del cinema e letteratura.

Lei è regista e poeta, nato a Genova nel 1995, autore del libro Venticinque e vincitore del premio “La via dei Libri” con L’età della Resa. Come è nata la sua passione per il cinema e In che modo la sua formazione letteraria ha influenzato e continua a influenzare il suo linguaggio cinematografico?
La letteratura entra profondamente nel mio cinema, proprio perché la mia formazione è umanistica. Ho trascorso un periodo della mia vita, circa due anni, immerso nella lettura: leggevo e studiavo i grandi classici – Dante, Oscar Wilde, Guy de Maupassant, Emily Brontë e molti altri. Credo che questo mi abbia aiutato a costruire una mia immaginazione cinematografica. Il potere di un libro è quello di farti immaginare una storia, di offrirti la libertà di seguire la tua narrazione; il cinema, invece, ti conduce dentro un “canale” visivo preciso. Sono nato come scrittore e poi sono diventato anche regista, come naturale estensione della mia necessità di raccontare le immagini che vedo scorrere nella mente. Il timbro letterario è molto marcato nei miei lavori cinematografici: la voce fuori campo che legge testi poetici, ad esempio, nasce proprio da questo percorso. Oggi lavoro anche per il teatro, e sto imparando un nuovo linguaggio narrativo: è affascinante studiare e attraversare forme diverse di racconto — da quello letterario-descrittivo, a quello per immagini del cinema, fino a quello asciutto e d’azione del teatro. Ma, a parte tutto questo, l’importante è poi avere qualcosa da raccontare: sentire quella necessità capace di muoverti in un mondo già decisamente raccontato.

La Ragazza delle Gardenie è in concorso al Catania Film Fest: qual è l’origine di questo progetto e cosa l’ha ispirata nella sua scrittura e regia?
La Ragazza delle Gardenie è un film nato dalla volontà di Sara Ciampi, poetessa genovese di 49 anni, di raccontare la storia della propria vita. In un giorno piovoso d’autunno ho ricevuto una sua chiamata: mi chiedeva di leggere un libro intitolato proprio La Ragazza delle Gardenie, scritto da sua madre, Lidia, e dedicato a lei. Incuriosito, l’ho acquistato e letto. Ciò che mi ha colpito di più nella narrazione è stato il tema del ricordo, quel legame sottile tra memoria e identità. Così ho chiamato Sara e le ho chiesto se potessi creare una nuova storia, mantenendo soltanto i nomi dei protagonisti e il titolo. Lei ha accettato, dandomi carta bianca. In pochi mesi è nata una sceneggiatura originale costruita su due piani temporali distinti ma profondamente connessi: il presente e il passato. Mi interessava raccontare la contemporaneità in relazione alla memoria, come se il tempo potesse dialogare con se stesso.Il film è ambientato in parte ai giorni nostri e in parte nel 1901. La protagonista, Alessandra (interpretata da Marta Gastini), è un ministro di Roma che conduce una vita frenetica. È costretta a tornare nella sua terra d’origine, nell’Alessandrino, per decidere se vendere o meno la casa di una vecchia prozia poetessa, Rosa, vissuta a inizio Novecento e affetta da tubercolosi cronica. Entrando nella casa, Alessandra ritrova il diario di Rosa e, tra le pagine, scopre la storia d’amore ideale — e mai consumata — tra la poetessa e un contadino al servizio della famiglia, Antonio (interpretato da Francesco Patanè). Dal punto di vista registico, ho cercato di realizzare inquadrature semplici ma eleganti, lavorando molto con la soggettiva, il controcampo e alcune carrellate. Mi interessava soprattutto raccontare attraverso i dettagli, perché sono quelli che definiscono l’ambiente e risaltano il mescolarsi delle due epoche storiche differenti.
Una delle inquadrature a cui sono più legato è quella che ritrae Rosa riflessa nella finestra della sua stanza, con in mano il diario: la poetessa gira una pagina, e in quell’istante vediamo Alessandra continuare a sfogliare lo stesso diario, come se il tempo avesse trovato un varco per unirle. Alla fine, Alessandra sceglie di non vendere la casa: la poesia, i sentimenti e quell’amore appassito tra le pagine del diario le ricordano l’importanza di rallentare, di fermarsi a respirare. Quella che doveva essere una semplice proprietà da vendere diventa un luogo da custodire, uno spazio di riflessione e di ritorno a se stessi.

Ha scelto interpreti di rilievo come Marta Gastini, Francesco Patanè e Steve Della Casa. Come ha costruito il cast e quali qualità cercava nei suoi protagonisti?
Sì, e sono molto contento di aver lavorato con loro. Francesco Patanè è un amico da molti anni, da prima che io diventassi regista e lui attore. Per me è stato naturale sceglierlo per il ruolo di Antonio: è un interprete capace, sensibile e molto umile. Di solito porta i capelli lisci, ma nel corto l’ho voluto con i ricci, perché Antonio — contadino costretto alla fatica ma con un animo poetico — rappresenta un po’ me stesso. Io sono riccio, e in qualche modo volevo che ci fosse questa somiglianza simbolica. Antonio è un personaggio che amo particolarmente dal punto di vista drammaturgico, perché cambia: è costretto a subire le angherie dei suoi due compagni, Beppe ed Ettore (interpretati da Raffaele Barca ed Ettore Scarpa), ma trova forza nella poesia e non rinuncia al sogno di una vita diversa.
La scommessa che Beppe gli propone — scrivere e consegnare una poesia alla poetessa Rosa e attendere una risposta che potrebbe liberarlo dal lavoro faticoso — diventa la sua occasione di crescita. È una metafora della vita: spingersi oltre, affrontare le proprie paure fino a farle diventare alleate.
Come diceva Eduardo De Filippo, “gli esami non finiscono mai”, e credo sia profondamente vero. Marta Gastini è un’attrice splendida. Quando mi è stata proposta, ho guardato alcune sue foto e video e ho capito subito che doveva essere lei la protagonista. Marta ha un volto antico e raffinato, recita con naturalezza e precisione, e mi ha colpito la sua disponibilità, la sua voglia di mettersi in gioco con umiltà e curiosità. Steve Della Casa, infine, è stata la ciliegina sulla torta. Mi serviva un attore capace di incarnare il sindaco del paese, una figura autorevole e al tempo stesso popolare: chi meglio di Steve? È uno dei massimi esperti di cinema in Italia, ma anche una persona semplice, generosa e ironica. È stato perfetto per il ruolo, e lavorare con lui è stato un vero piacere: ogni momento sul set con Steve è stato un arricchimento e, soprattutto, un divertimento.
Il rapporto tra regista e attori è fondamentale per la buona riuscita di un film. Quando si trova a dirigere degli attori su cosa lei basa questa relazione?
Io, con gli attori con cui collaboro, cerco sempre un’intesa speciale. Non riesco a lavorare se non sento che c’è quel feeling autentico, fatto di ascolto reciproco e di scambio. Ho bisogno di conoscerli come esseri umani, per aiutarli a recitare in modo genuino; ma allo stesso tempo devo anche un po’ idealizzarli, per consentire la piena riconoscenza di un ruolo.
Credo che la relazione tra regista e attore funzioni davvero solo quando c’è libertà espressiva all’interno di una struttura precisa. Ricordo, ad esempio, che sul set — durante la registrazione delle voci fuori campo, la parte più difficile per un attore — Martafaticava a ritrovare la giusta temperatura emotiva. Così le ho chiesto di chiudere gli occhi e di lasciarsi trasportare dalle mie parole: parafrasando la poesia che doveva leggere, ho cercato di farle arrivare quell’emozione che in quel momento le mancava. Ed è bastato poco, un istante di fiducia, perché la sua voce trovasse la verità che cercavamo.
Qual è, secondo lei, il valore culturale e professionale di un festival come quello di Catania per il cinema indipendente? Indecifrabilmente altissimo, senza ombra di dubbio.
I festival di cinema indipendente — la maggior parte in Italia — sono fondamentali per mostrare il proprio lavoro, per respirare l’ambiente del cinema e per capire con chi si vuole condividere il proprio percorso. Durante un festival possono nascere collaborazioni, confronti e persino nuove amicizie artistiche: è un terreno fertile per chi ama raccontare. Catania Film Fest è un festival che stimo molto per la sua scelta autoriale. Emanuele Rauco è un grandissimo critico e appassionato di cinema, capace, schietto e profondamente onesto nel suo sguardo. Ben vengano i festival senza tappeti rossi, senza glamour, ma costruiti attorno a un tavolo imbandito, con un bicchiere di vino e la voglia autentica di parlare di cinema, società e cultura. Viva il Catania Film Festival.

Il festival ospita il documentario Nuova alba, dedicato all’intelligenza artificiale. Qual è la sua posizione sul rapporto tra tecnologia e creatività artistica?
Il mio rapporto con la tecnologia è abbastanza semplice, direi essenziale. Conosco le tecniche standard, quelle basilari, ma non vado oltre: non ho mai usato TikTok, per esempio, e sinceramente non saprei nemmeno da dove cominciare.
Quando scrivo, preferisco sempre annotare a mano gli argomenti o le idee principali prima di passare al computer. Lo faccio soprattutto quando lavoro a un libro: mi serve il contatto fisico con la carta, la lentezza della scrittura manuale. Ovviamente, non amo l’idea che si usi l’intelligenza artificiale per scrivere sceneggiature o drammaturgie teatrali. Finora rimango un po’ guardingo, perché credo che la creatività umana non possa essere sostituita da un algoritmo. Detto questo, non voglio demonizzare la tecnologia: può essere uno strumento utile, se usato con misura. Deve rimanere un supporto, non un sostituto. Può aiutarci a semplificare certi processi o a ridurre lo stress del lavoro, ma il cuore di ogni opera deve restare umano.
Ha già in cantiere nuovi progetti? Può anticipare qualcosa?
Tra non molto uscirà un mio documentario sul tema della pesca consapevole nel 2025, co-diretto con Edoardo Nervi: Elia – un racconto di mare e per il mare. Racconta la storia di un pescatore genovese, Elia Orecchia, e il suo rapporto con il mare e la sostenibilità. A gennaio porterò in scena uno spettacolo teatrale che sto scrivendo con Massimo Olcese (non è mio padre), dedicato alla violenza di genere e digitale. Sarà in cartellone al Teatro Alessandrino, un grande onore e una responsabilità enorme. Sto inoltre ultimando un romanzo psicologico, La Salita del Melograno. Subito dopo, lavorerò a un documentario su una figura storica del teatro genovese, ma al momento non posso ancora svelare nulla. Infine, sto iniziando a pensare al mio primo lungometraggio, anche se forse è ancora presto per parlarne concretamente.
@Riproduzione Riservata
…

Maria Sole Stancampiano

Antonella la Mantia