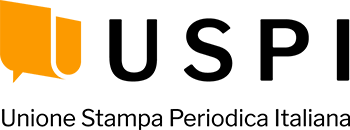Tra chat, porte chiuse, sguardi sfidanti e fragilità invisibili: perché accompagnare un figlio o una figlia di 13 anni oggi fa paura, stanca, confonde, ma può diventare uno dei luoghi più veri dell’amore.
Dedicato a mia figlia Kiara
Tredici anni è una frontiera strana.
Non sono più bambini, non sono ancora grandi. Hanno il corpo che corre avanti e l’anima che a volte resta indietro. Cambiano voce, cambiano gusti, cambiano umore cinque volte nell’arco di un pomeriggio. E nel mezzo, ci sono loro: i genitori. Stanchi, spesso spaventati, a volte arrabbiati, quasi sempre pieni di amore e di senso di inadeguatezza.
È difficile essere genitori, sempre.
Ma essere genitori di un tredicenne oggi significa stare in mezzo a un terremoto silenzioso che riguarda identità, relazioni, tecnologia, scuola, futuro.
Significa tenere insieme la paura che “gli succeda qualcosa” e il bisogno di lasciarli andare.
Significa dire “fidati di me” mentre dentro ti chiedi se ti fideresti tu, al posto loro.
Uno dei nodi più dolorosi, spesso inconsapevole, è l’incoerenza. Non quella cattiva delle bugie, ma quella fragile di chi non sa più come muoversi.
Chiediamo ai ragazzi di essere responsabili, ma poi non riusciamo a lasciarli andare da soli a fare due passi.
Gli diciamo “fidati di te stesso”, ma poi controlliamo ogni compito, ogni voto, ogni chat.
Li invitiamo a “parlare di tutto”, ma quando tirano fuori qualcosa che ci spaventa, cambiamo discorso, minimizziamo o ci arrabbiamo.
Loro non hanno le parole per dirlo, ma lo sentono.
Sentono che il mondo adulto è un luogo in cui anche i grandi hanno paura, anche i grandi sono persi. E spesso reagiscono chiudendosi, opponendosi, diventando sarcastici, sfidanti, oppure rifugiandosi in un altrove digitale dove pare tutto più facile.
Non siamo ipocriti: siamo fragili.
Ma se non lo riconosciamo, quella fragilità diventa muro.
Se invece la mettiamo in parola — “guarda, non so sempre cosa fare, ma ci sono” — allora diventa ponte.
Le paure dei genitori di oggi sono spesso diverse da quelle di una volta, ma in fondo hanno lo stesso volto: la paura di perdere i propri figli.
Perderli perché il mondo è percepito come pericoloso.
Perderli perché l’online sembra una giungla incontrollabile.
Perderli perché la scuola non basta più a dare strumenti di senso.
Perderli perché sentiamo di non avere più “presa” su ciò che vivono.
C’è la paura che “capitino brutte compagnie”, che cadano in dipendenze, che facciano scelte sbagliate, che stiano male e non ce lo dicano. E c’è una paura più sottile, quasi innominabile: la paura che un giorno ci guardino negli occhi e dicano “tu non c’eri”, anche se abbiamo fatto di tutto per esserci.
Questa paura a volte ci rende più controllanti, più rigidi, più moralisti. Altre volte, al contrario, ci fa mollare: “fate quello che volete, tanto non mi ascoltate”.
La verità è che, a tredici anni, hanno ancora bisogno di noi.
Ma non come guardiani del cancello: come adulti di riferimento.
Non come poliziotti del loro mondo, ma come interlocutori veri.
A tredici anni si è un paradosso vivente.
Da fuori sembra che abbiano solo voglia di sfidare, ridere, stare con i coetanei, provare tutto. Da dentro, però, spesso c’è un miscuglio di insicurezza e desiderio di essere visti per ciò che sono, non solo per ciò che fanno.
Sono più esposti di noi alla pressione sociale: like, giudizi, confronti continui con i corpi, le vite, le storie degli altri. Hanno una finestra sul mondo in tasca, ma strumenti emotivi ancora acerbi per reggere quel flusso. Si affacciano su domande profonde: chi sono? valgo? sono abbastanza? dove appartengo?
E allora sì, il cellulare può diventare rifugio.
La chat può diventare il luogo in cui sentono di contare qualcosa.
Il gruppo può sostituire, almeno in parte, il calore di casa quando questo calore è intermittente o confuso.
Non significa che dobbiamo accettare tutto, né rinunciare a dare limiti.
Ma se non vediamo la loro fatica, se riduciamo tutto a “sei sempre attaccato al telefono” o “alla tua età io…”, rischiamo di mancare l’appuntamento più importante: essere per loro uno spazio in cui possono esistere con tutto il pacchetto di caos che si portano dentro.
La fatica si gioca spesso nelle cose semplici: l’orario di rientro, il tempo sugli schermi, il rendimento scolastico, gli amici “giusti” o “sbagliati”.
Qui non esiste una formula magica. Esistono domande sane:
- Questa regola serve a proteggerti o solo a tranquillizzare me?
- Sto mettendo un confine per amore o per paura?
- Ti sto ascoltando davvero o sto solo aspettando il tuo silenzio per dire la mia?
- Ti sto chiedendo qualcosa che io, alla tua età, non avrei mai accettato?
Essere genitori di un tredicenne oggi significa negoziare continuamente: tra controllo e fiducia, tra protezione e libertà, tra “è per il tuo bene” e “sto proiettando su di te ciò che non ho vissuto io”.
Non è facile, non lo è per nessuno.
Ma il criterio non è non sbagliare mai: è esserci quando si sbaglia, riconoscerlo, riaprire la conversazione.
In mezzo a tutta questa fatica, c’è una bellezza immensa che spesso ci dimentichiamo di nominare: a tredici anni un figlio, una figlia, stanno nascendo una seconda volta.
La prima è stata quella fisica, tra pianti, notti in bianco e primi passi.
Questa volta la nascita è interiore: sta venendo alla luce una persona unica, con pensieri propri, gusti propri, intuizioni che non sono copie dei nostri desideri.
Essere genitori in questo tempo significa assistere a un parto lento, disordinato, pieno di imprevisti.
Ma significa anche poter vedere in diretta come si accende uno sguardo quando qualcosa li appassiona davvero, come si raddrizzano le spalle quando si sentono rispettati, come il loro senso di giustizia li fa diventare duri e teneri allo stesso tempo.
La bellezza sta in quei momenti in cui, all’improvviso, un tredicenne che fino al giorno prima ti rispondeva a monosillabi ti fa una domanda enorme sulla vita, sulla morte, su Dio, sull’amore. O in quei minuti rubati in macchina, dopo un allenamento o una serata, in cui si apre uno spiraglio e da lì passa un pezzo di verità.
Sta nel coraggio di chi, pur sbagliando, ci prova.
Nel sorriso storto con cui ti dicono “scusa”.
Nel modo in cui ti cercano, senza ammetterlo, quando il mondo fuori li fa sentire troppo piccoli.
Forse la sfida più grande, oggi, è uscire dall’idea di dover essere genitori perfetti. I figli non hanno bisogno di adulti senza crepe: hanno bisogno di adulti che non scappano davanti alle crepe.
Possiamo dire: “Ho paura anch’io”.
Possiamo dire: “Non so come si fa, ma posso imparare con te”.
Possiamo dire: “Su questo non sono d’accordo, ma voglio capire cosa senti”.
Possiamo, soprattutto, continuare a stare.
Tornare a bussare alla porta chiusa, non per controllare, ma per dire: “Quando vuoi, sono qui”.
In un mondo che corre, che consuma relazioni, che trasforma tutto in prestazione, essere genitori di un tredicenne è uno degli atti più radicali di fiducia nel futuro.
È scegliere ogni giorno di non arrendersi al cinismo, alla rinuncia, all’indifferenza.
È continuare a credere che, dietro gli sbuffi, le risposte taglienti, le occhiate al cielo, ci sia ancora quel bambino, quella bambina, che una volta ci cercava con le braccia alzate. Solo che oggi ha bisogno di essere abbracciato in un altro modo: riconosciuto come persona.
La difficoltà è enorme.
La bellezza, se restiamo, lo è ancora di più.
@Riproduzione riservata Francesco Mazzarella