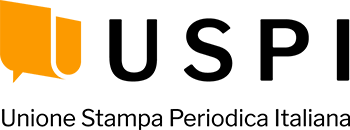Quando una notte di festa si trasforma in assenza, le famiglie non perdono solo una vita: perdono la normalità.
di Francesco Mazzarella
Ci sono notizie che si leggono con gli occhi e poi, all’improvviso, si sentono nello stomaco. La strage di Crans-Montana è una di quelle. Perché non parla solo di un fatto accaduto “altrove”. Parla di ciò che può accadere a chiunque, in qualunque casa, in qualunque famiglia: un attimo prima un messaggio, un saluto, una risata; un attimo dopo il buio, il vuoto, l’incredulità.
Di fronte a tragedie così, la dinamica diventa quasi secondaria. Non perché non conti la verità – conta, eccome – ma perché prima ancora c’è la sostanza più dura: il dolore di chi resta. Il dolore di chi, da un minuto all’altro, si ritrova a fare i conti con una parola che non voleva pronunciare: “mai più”.
Io sono padre di una ragazza di 14 anni. E quando penso ai genitori che hanno perso un figlio o una figlia, non riesco a restare sul piano della cronaca. Perché so cosa significa attendere un rientro, controllare l’orologio, sentire un rumore di chiavi e tirare il fiato. So cosa significa amare qualcuno così tanto da avere paura perfino dei pensieri. E immagino – con rispetto, con pudore, con tremore – cosa significhi invece aspettare una risposta che non arriva, chiamare e richiamare, sperare e poi crollare. Quell’altalena che lacera: un barlume, un silenzio, un altro barlume, un’altra frattura.
Il dolore delle famiglie non è solo pianto. È confusione, è stordimento, è una casa che improvvisamente cambia voce. È il letto che resta intatto, è il nome che nessuno osa dire ad alta voce, è il corpo che continua a respirare mentre il cuore non capisce come si faccia. È anche rabbia, a volte. E senso di colpa, quasi sempre: quello che nasce dall’amore quando non può più proteggere. Un sentimento ingiusto, ma potentissimo.
E poi c’è una cosa che spesso chi sta fuori non vede: il dopo. Perché l’attenzione pubblica passa, le notifiche scendono, il mondo riparte. Loro no. Loro restano in quel punto, in quell’ora, in quell’ultima frase. E lì serve la forma più vera di rispetto: non curiosità, non commenti, non frasi veloci. Serve presenza. Serve delicatezza. Serve qualcuno che non si stanchi, che non sparisca quando la vita “normale” riprende.
Forse l’unica cosa che possiamo fare, senza invadere, è questo: custodire quel dolore come si custodisce una cosa sacra. Evitare di trasformarlo in argomento, in disputa, in spettacolo. E lasciare che ci cambi. Che ci renda più attenti, più sobri, più umani. Che ci ricordi che ogni figlio che esce di casa non è “solo” un ragazzo o una ragazza: è un universo che qualcuno ama con tutta la vita.
Alle famiglie colpite non si può chiedere forza. Si può solo offrire rispetto. E silenzio buono. E vicinanza vera. Perché certi dolori non si spiegano: si accompagnano.
@riproduzione riservata