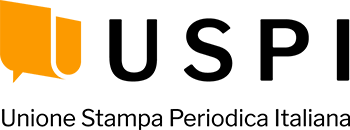Quando i dossier diventano spettacolo e le vittime restano persone: la domanda che questa storia ci costringe a non rimandare
Ci sono vicende che non finiscono quando finisce la cronaca. Restano lì, come un nodo in gola della società. Il caso Epstein è una di queste: non perché “non sappiamo”, ma perché quello che sappiamo — e il modo in cui lo sappiamo — ci mette davanti a uno specchio scomodo. E oggi, aggiornato a ciò che sta accadendo in queste settimane, quello specchio è ancora più nitido: non siamo solo davanti a un criminale e alla sua rete. Siamo davanti a un sistema di potere che ha imparato a sopravvivere anche quando viene esposto.
Negli Stati Uniti, la nuova ondata di pubblicazioni di documenti da parte del Dipartimento di Giustizia, prevista e imposta dall’Epstein Files Transparency Act (diventato legge il 19 novembre 2025) e culminata in un ulteriore rilascio di milioni di pagine a fine gennaio 2026, ha riaperto non solo archivi, ma nervi scoperti. A colpire non è soltanto la mole (milioni di pagine, migliaia di video e immagini), ma l’effetto collaterale: l’opinione pubblica viene travolta da un mare di carte, mentre il cuore della questione — responsabilità, complicità, omertà istituzionale — rischia di perdersi in un labirinto.
E qui emerge il primo senso profondo: la trasparenza, da sola, non è giustizia.
La trasparenza è un mezzo. La giustizia è un percorso. Pubblicare documenti può diventare un gesto reale di accountability, ma può anche trasformarsi in una strategia di contenimento: “vi diamo tutto”, così vi stancate, vi confondete, vi dividete. Non è una teoria astratta: lo si vede quando la discussione pubblica si sposta dal dolore delle vittime alla caccia ai nomi, dalle responsabilità alle fazioni, dalla domanda di riparazione al tifo. Anche la politica, negli ultimi giorni, mostra quanto questo caso sia diventato un campo di battaglia identitario, capace di spaccare schieramenti e alimentare sospetti reciproci più che percorsi di verità condivisa.
La seconda verità che questa situazione ci mette davanti è più amara: il potere non ha bisogno di essere innocente per restare in piedi; gli basta essere opaco.
Epstein non era “solo” un predatore. Era un predatore che ha potuto agire perché esiste un ecosistema che rende possibile il predatore: complicità sociali, fascinazione per il denaro, culto dell’accesso, istituzioni lente o cieche, professionisti che guardano altrove, mondi interi che scambiano l’influenza per autorevolezza. E quando quel sistema viene chiamato a rispondere, spesso risponde con la sua arma più efficace: la diluizione. Troppi documenti, troppe piste, troppe “versioni”, troppe narrative parallele. Il rumore diventa una forma di anestesia.
C’è poi un altro livello, oggi particolarmente evidente: la geografia del silenzio.
La notizia che il New Mexico intende riaprire l’attenzione investigativa attorno al ranch di Epstein — con la spinta politica e pubblica a ottenere accesso pieno ai fascicoli federali e un lavoro istituzionale dedicato — è un segnale potente, perché ricorda una cosa semplice: non tutti i luoghi sono stati guardati allo stesso modo. E quando un luogo non viene guardato, non è “solo” una mancanza operativa: diventa un simbolo. Diventa la prova che esistono periferie della giustizia, zone grigie dove l’urgenza evapora. Non è solo “cosa è successo lì”. È perché quel lì è stato lasciato in penombra.
In questo scenario, la figura di Ghislaine Maxwell — condannata e con l’ultimo passaggio alla Corte Suprema non accolto nell’ottobre 2025 — resta un altro specchio: una donna dentro la macchina giudiziaria, ma anche la dimostrazione che la rete è più grande del singolo anello. Quando una storia di traffico e abuso sistemico finisce per avere “un volto solo” penalmente condannato, la società prova una strana sensazione: come se la colpa fosse stata archiviata insieme alla pena. Ma il dolore non si archivia. E soprattutto: il sistema che ha permesso non si spegne automaticamente.
Ed ecco la domanda che, secondo me, oggi questa vicenda ci mette davanti con forza: noi cosa cerchiamo davvero, quando diciamo “vogliamo la verità”?
Se cerchiamo la verità come elenco — nomi, contatti, foto, date — rischiamo di trasformare il male in un database e la sofferenza in una curiosità. Se cerchiamo la verità come processo — responsabilità, prevenzione, riparazione — allora la storia cambia direzione. Perché la verità vera non è una collezione di file: è una conversione di sguardo. È decidere che la vulnerabilità non sarà più moneta di scambio nei salotti del mondo.
C’è un punto, però, che va detto con delicatezza e fermezza: questa storia ci tenta continuamente con un equivoco morale.
L’equivoco è: “se scopro che anche il mio avversario è dentro, allora ho ragione.”
Ma qui non c’è “ragione” da avere. Qui c’è un male da disinnescare. E il male non si disinnesca con l’umiliazione pubblica degli altri: si disinnesca con regole, controlli, cultura, cura delle vittime, coraggio istituzionale. Altrimenti la verità diventa solo carburante per nuove guerre, e intanto le persone ferite restano a guardare il mondo che usa la loro storia per colpirsi a vicenda.
Il senso, allora, non è “cosa è successo”, ma cosa ci rivela il fatto che sia potuto succedere così, per così tanto, con così tante porte aperte.
Ci rivela che il prestigio sociale può essere una maschera potentissima.
Ci rivela che la ricchezza crea corridoi preferenziali anche nella percezione morale: “se frequenta certi ambienti, non può essere davvero così”.
Ci rivela che la reputazione, spesso, vale più della vita di una ragazza senza protezione.
E ci rivela anche una fragilità collettiva: la nostra difficoltà a stare davanti al dolore senza trasformarlo in intrattenimento.
E poi c’è il tema che, come comunicatore, non posso ignorare: la comunicazione è parte del problema, e può diventare parte della soluzione.
Quando un caso esplode, l’algoritmo premia la semplificazione, la polarizzazione, il dettaglio scandaloso. È umano: ciò che fa orrore attira. Ma è proprio qui che la maturità di una società si vede: nella capacità di non ridurre la giustizia a un trend. La verità non è un reel. Le vittime non sono un pretesto. I documenti non sono un gioco di ruolo.
E allora, se devo dire qual è il senso che questa fase “aggiornata ad oggi” ci consegna, è questo: il nostro compito non è consumare la verità, ma prendercene cura.
Prendercene cura significa chiedere che la trasparenza sia leggibile, verificabile, orientata alle responsabilità e non solo alla quantità.
Significa pretendere che le istituzioni guardino anche dove non hanno guardato prima, e che lo facciano con strumenti e coraggio, non con comunicati.
Significa proteggere chi parla, sostenere chi denuncia, creare spazi in cui la vergogna cambi direzione: non più sulle vittime, ma su chi ha usato il potere per ferire.
Perché il punto, alla fine, è semplice e terribile: se Epstein è potuto esistere così, non è solo per ciò che lui ha fatto, ma per ciò che molti hanno permesso. E il “molti” non è sempre un nome famoso. A volte è una porta chiusa. Un dubbio ignorato. Una battuta lasciata passare. Un favore accettato. Un silenzio venduto come prudenza.
La speranza — l’unica speranza credibile — non sta nell’ennesimo file che “inchioda” qualcuno. Sta nel fatto che questa storia, se la affrontiamo con dignità, può cambiare le regole del gioco: più protezione reale per i minori, più responsabilità per chi gestisce potere e denaro, più strumenti per indagare senza paura, più cultura della relazione sana, più educazione affettiva, più presidio comunitario.
…E soprattutto: può lasciarci una lezione che non va “capita”. Va incisa. Perché se la dimentichi, la paghi.
Il potere più pericoloso non è quello che urla: quello si vede, si riconosce, si può combattere.
Il più pericoloso è quello che sussurra. Quello che ti addestra alla prudenza finché la prudenza diventa complicità. Quello che ti fa credere che tacere sia eleganza, equilibrio, “responsabilità”. E intanto, nel silenzio, qualcuno viene schiacciato.
Oggi è il caso di parlare. E non con la voce della curiosità, ma con la voce della coscienza.
Non per fare spettacolo, ma per fare luce.
Non per vincere una guerra di fazioni, ma per spezzare una catena.
Parlare bene, sì. Ma non mansueti.
Con rispetto per le vittime, ma senza rispetto per i meccanismi che le hanno rese invisibili.
Con verità che brucia, perché solo ciò che brucia davvero può disinfettare.
E con una giustizia che non sia un titolo, ma un cammino: duro, ostinato, e finalmente umano.
@Riproduzione riservata Francesco Mazzarella