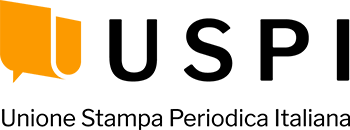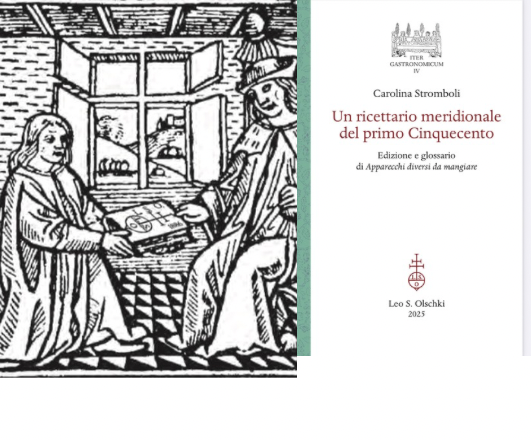Carolina Stromboli riporta alla luce un ricettario del 1524, preziosa testimonianza della cultura gastronomica napoletana tardo-medievale tra lingua, storia e sapori . Zucchero, spezie e mandorle, ma non solo: i sapori del tempo nella preziosa edizione di Leo Olschki per la collana “Iter Gastronomicum“
Avete mai assaggiato una almogiavola? O una salce dodina con mirastro di piccione e pumata bureglia? Dietro questi nomi antichi e misteriosi si nasconde un mondo di sapori, spezie, aromi e rituali che ci riportano dritti al cuore della cucina: con “Un ricettario meridionale del primo Cinquecento- Edizione e glossario di Apparecchi diversi da mangiare”, Carolina Stromboli ci accompagna in un viaggio affascinante tra le pagine di un manoscritto del 1524, riscoprendo — con sguardo da linguista e passione da esploratrice del gusto — un patrimonio dimenticato di cultura gastronomica e lessico popolare.
Il volume, pubblicato nella collana “Iter Gastronomicum” dell’editore fiorentino Olschki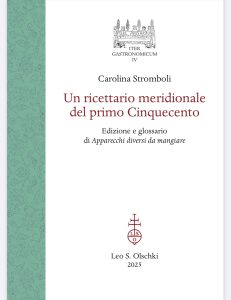 , presenta l’edizione critica di un prezioso ricettario conservato alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Si tratta di 86 ricette, redatte in volgare meridionale, che raccontano una cucina ricca, profumata, stratificata e sorprendentemente raffinata.
, presenta l’edizione critica di un prezioso ricettario conservato alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Si tratta di 86 ricette, redatte in volgare meridionale, che raccontano una cucina ricca, profumata, stratificata e sorprendentemente raffinata.
Il testo si chiude con una data precisa: “Scripto in Nerula lo anno 1524 a di 3 de agusto”. Per lungo tempo si è pensato che “Nerula” indicasse Lagonegro (Lucania), ma grazie agli studi più recenti — in particolare di Lejla Mancusi Sorrentino e dell’autrice stessa — si è stabilito che il luogo più plausibile è Nerola, nella Sabina romana. Tuttavia, il cuore culturale e linguistico del ricettario batte decisamente a Sud: Napoli e la sua corte aragonese emergono con forza nelle preparazioni, nella terminologia e nella sensibilità culinaria del manoscritto.
Una scoperta affascinante è celata tra le ultime carte: una frase scritta al contrario rivela, forse, l’identità dell’autore. Si tratta di Anton Camuria, nome finora privo di riscontri documentari, ma plausibilmente appartenente a un cuoco professionista o a un copista della cerchia aristocratica partenopea. In ogni caso, l’opera è intrisa della competenza tecnica e dell’esperienza diretta di chi conosceva a fondo l’arte di cucinare per una corte nobile.
Il ricettario è un piccolo capolavoro di tecnica culinaria. Le ricette — spesso introdotte da formule come “Per fare lo mirastro” o “Piglia uno rotulo de insognia” — sono dettagliate e ordinate con metodo, nonostante l’approssimazione di alcune dosi: spesso “quanto pare a vui. Tra gli ingredienti più frequenti troviamo zucchero (presente in 73 ricette su 86), cannella, mandorle, pepe, zenzero, uova e formaggi come caciocavallo e provola.
Non mancano carne (specie di piccione), frutta secca, datteri, acqua di rose e agrumi. Alcuni piatti, come “la turta de russi de ova”, prevedono fino a cento tuorli, a testimonianza della ricchezza di una cucina aristocratica e sontuosa. Il lessico tecnico è minuzioso, e le tecniche di cottura — bollitura, frittura, arrosto — si alternano con accostamenti dolce-salato oggi considerati sorprendenti.
“Apparecchi diversi da mangiare” si inserisce nel fitto intreccio della tradizione gastronomica italiana tardo-medievale e rinascimentale, dialogando con opere fondamentali come:
- il Libro de arte coquinaria di Maestro Martino, capostipite del genere;
- l’Anonimo napoletano (ms. Bühler), affine per contesto e stile;
- il Modo singulare de cucina (ms. Egerton), con cui condivide numerose ricette;
- il ricettario Wellcome, dalla struttura più ampia ma con forti corrispondenze;
- il catalano Libre del coch di Roberto de Nola, cuoco di re Ferrante d’Aragona.
I confronti testuali proposti da Carolina Stromboli sono uno dei punti di forza del volume. Le ricette comuni, le somiglianze formali, le influenze iberiche (in particolare catalane) e gli arabismi come coscossone (couscous) e almogiavole (frittelle di ricotta), testimoniano la complessità culturale di un’epoca in cui la cucina era terreno di scambio tra mondi lontani.
Il ricettario, curato con perizia filologica e arricchito da un glossario dettagliato è uno strumento prezioso per linguisti, storici, studiosi della cucina ma e’ anche per chi ama curiosare tra i sapori perduti, per chi crede che il cibo sia una forma di racconto e che ogni parola — anche la più arcaica — possa contenere un mondo. È un invito a sedersi alla tavola della storia, ad ascoltare la voce dimenticata di un cuoco del Cinquecento, a scoprire quanto può essere moderno un piatto antico. Perché, alla fine, cucinare è sempre un modo per ricordare. E leggere questo libro è un modo per ritrovare — tra spezie, manoscritti , lingua e memoria — il sapore di ciò che siamo stati.
@riproduzione riservata