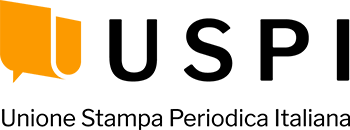La storia della “famiglia del bosco” di Palmoli non è solo una cronaca di tribunale. È uno specchio che ci costringe a chiederci dove finisce la libertà di scegliere come vivere e dove inizia il dovere, anche duro, di proteggere i bambini. Al centro non c’è un bosco romantico, né un mostro istituzionale: ci siamo noi, con le nostre paure, le nostre idealizzazioni e la fatica di tenere insieme diritti, affetti e responsabilità.
Certe storie esplodono all’improvviso nel dibattito pubblico, come se il Paese intero si risvegliasse di colpo davanti a una domanda che teneva sotto il tappeto da anni. La vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli, in Abruzzo, è una di queste. Una coppia anglo–australiana, tre bambini, una casa isolata nei boschi, niente allacci alla rete, una scelta di vita alternativa e radicale. Poi un’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che dispone l’allontanamento dei figli e la sospensione della responsabilità genitoriale. E, subito dopo, il diluvio: talk show, post indignati, accuse ai giudici, difese a oltranza dei genitori, strumentalizzazioni politiche.
I genitori si chiamano Nathan Trevallion, inglese, e Catherine Birmingham, australiana. Negli ultimi anni hanno scelto di lasciare uno stile di vita “normale” per costruire un’esistenza essenziale, a contatto con la natura, in un casolare tra i boschi di Palmoli, nel Chietino. La loro storia è stata raccontata in interviste e programmi televisivi come un sogno di libertà: pannelli solari, autoproduzione, istruzione alternativa, pochi oggetti, tanto tempo insieme. Una narrazione che ha affascinato molti, soprattutto in un’epoca in cui la vita urbana sembra sempre più disumanizzante. Proprio questo rende il caso ancora più delicato: perché tocca corde profonde del nostro immaginario, tra desiderio di fuga e bisogno di protezione.
In mezzo, quasi invisibili, tre bambini che da un giorno all’altro si sono ritrovati sradicati dalla loro casa, dalle loro abitudini, dai loro genitori. E un Paese diviso tra chi grida allo Stato che “ruba i figli” e chi, al contrario, difende a priori la scelta dei magistrati. In realtà, come spesso accade, la verità è meno urlata e molto più complessa.
Per provare a capire bisogna partire dai fatti. L’ordinanza del 13 novembre 2025 arriva al termine di un percorso iniziato mesi prima, dopo un episodio di intossicazione da funghi che aveva coinvolto la famiglia e fatto scattare l’intervento dei servizi sociali. Da lì si apre un’istruttoria: sopralluoghi, relazioni, accertamenti. Secondo la ricostruzione pubblicata da diverse testate e confermata da una nota giuridica di “Giustizia Insieme”, i giudici accertano che i bambini vivevano in una casa definita “rudere privo di corrente elettrica, gas e servizi sanitari”, in condizioni abitative giudicate disagevoli e insalubri, con criticità igieniche evidenti, in una zona isolata, difficilmente raggiungibile in caso di emergenza.
Ma non è solo una questione di muri e impianti. Il Tribunale sottolinea anche la deprivazione della vita di relazione: i bambini non frequentavano la scuola in presenza, non avevano coetanei con cui confrontarsi, non risultavano essere stati visitati da un pediatra fino all’estate 2025 e non era possibile, secondo gli atti, verificare lo stato vaccinale perché i genitori avrebbero rifiutato di consegnare i libretti sanitari e di consentire esami di controllo. L’ordinanza parla di pericolo per l’incolumità fisica e per lo sviluppo equilibrato dei minori, non solo sul piano sanitario ma anche relazionale. In altre parole, per i giudici, non bastava che i bambini fossero amati: bisognava che fossero anche oggettivamente tutelati.
A questo quadro si aggiunge un elemento giuridico non secondario. Il provvedimento si richiama esplicitamente al principio del “miglior interesse del minore”, richiamato dalla Convenzione Onu del 1989 e dall’articolo 30 della Costituzione italiana, che afferma il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, ma prevede anche l’intervento della Repubblica quando questo compito viene disatteso. È questo il punto sensibile: quando una scelta educativa radicale diventa, per lo Stato, una violazione di diritti fondamentali? E chi decide quando questa soglia è stata superata?
C’è poi un elemento che ha pesato molto nella decisione e che è stato ricordato da diverse analisi indipendenti: la scelta dei genitori di esporsi mediaticamente, portando la propria storia in televisione e sui social mentre il procedimento era in corso. Il Tribunale legge questo comportamento come “strumentalizzazione” dei figli a fini processuali, cioè come tentativo di usare l’opinione pubblica per influenzare l’esito del giudizio invece di confrontarsi nelle sedi istituzionali. Per i giudici, questo atteggiamento rappresenta una violazione ulteriore dei diritti dei bambini, esposti a un’esposizione mediatica sproporzionata rispetto alla loro età e fragilità. È uno dei passaggi più controversi, perché tocca il confine sottile tra diritto di raccontarsi e rischio di esporre troppo chi non può scegliere.
Allo stesso tempo, nei giorni successivi all’ordinanza emergono altri dati che complicano il quadro. Il Ministero dell’Istruzione chiarisce, sulla base della documentazione disponibile, che l’obbligo scolastico risulta assolto: i bambini erano regolarmente iscritti e seguiti in un percorso formale, pur con modalità particolari. Alcuni commentatori ricordano che in Italia esiste la possibilità di istruzione parentale e che migliaia di famiglie la praticano in modo legittimo. Non è quindi la sola scelta educativa “non standard” a motivare il provvedimento. Questo punto è importante, perché smentisce una delle narrazioni più diffuse: non è vero, almeno sulla carta, che i figli siano stati tolti “perché facevano scuola nel bosco”.
Per comprendere meglio, bisogna ricordare cosa prevede il nostro ordinamento. La responsabilità genitoriale può essere limitata o sospesa solo quando si ritiene che i minori siano esposti a un “pregiudizio grave e attuale” per la loro incolumità e il loro sviluppo. Non basta una scelta discutibile; non basta uno stile di vita alternativo; non basta neppure la povertà materiale. Occorre che vi sia, secondo le prove raccolte, una lesione dei diritti fondamentali del bambino: alla vita, alla salute, alle relazioni, alla crescita armonica. È questa la soglia che il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila dice di aver visto superata, evocando non solo le condizioni della casa, ma il rifiuto di collaborare alle verifiche sanitarie e il rischio di isolamento relazionale.
Siamo allora di fronte a un conflitto più profondo: da una parte il diritto–dovere dei genitori di scegliere il proprio stile di vita e il proprio progetto educativo, dall’altra il dovere dello Stato di intervenire quando ritiene che siano compromessi diritti fondamentali dei minori, come la salute, la sicurezza e la possibilità di sviluppare relazioni adeguate alla loro età. Il diritto parla di “responsabilità genitoriale”, non più di “potestà”: un termine che richiama non un potere, ma un compito. E quando questo compito, secondo i giudici, viene esercitato in modo gravemente carente, scatta la possibilità estrema dell’allontanamento.
È qui che la storia della “famiglia del bosco” ci obbliga a uscire dagli slogan. Perché ci mette davanti a una domanda disturbante: fino a che punto la libertà adulta può spingersi quando coinvolge bambini che non possono scegliere? Vivere in un bosco, lontano dal rumore delle città, dalla pressione dei social, dal consumismo, può essere una scelta spirituale, ecologica, persino profetica. Ma può diventare problematica se significa isolamento sociale totale, impossibilità di accedere alle cure, rifiuto sistematico di ogni verifica sanitaria, mancanza di qualunque rete di protezione.
Non possiamo neppure dimenticare che la vicenda è esplosa dentro un clima politico e mediatico già polarizzato. Alcuni esponenti di governo si sono schierati a favore della famiglia, evocando il pericolo di uno Stato “che si prende i figli delle persone normali”. L’Associazione nazionale magistrati ha difeso l’indipendenza del Tribunale, mentre la presidente del collegio si è trovata nel mirino di campagne d’odio personali, con la diffusione del suo recapito e del suo indirizzo. In poche ore, una vicenda di tutela minori è diventata un campo di battaglia ideologico: da una parte la paura di uno Stato invadente, dall’altra quella di famiglie irresponsabili. Il risultato è che il dibattito si è spostato lontano da ciò che dovrebbe restare centrale: la vita concreta di tre bambini.
D’altra parte, sarebbe troppo facile immaginare lo Stato come un’entità neutra e infallibile. Anche le istituzioni possono sbagliare, sottovalutare alcune dimensioni affettive, non capire il valore di stili di vita alternativi, faticare a entrare nel vissuto reale delle famiglie. Non va dimenticato che la stessa ordinanza è stata seguita da un’ondata di odio contro la presidente del Tribunale e i magistrati coinvolti, con minacce, insulti, diffusione dell’indirizzo di casa sui social. Segno di un clima avvelenato, in cui la giustizia viene ridotta a bersaglio, non a spazio di confronto.
Il rischio, in casi come questo, è che nessuno ascolti davvero nessuno. Da una parte si mitizza la “famiglia del bosco” come simbolo di purezza contro il sistema, dall’altra si difende il provvedimento come intoccabile, come se non si potesse mai discutere nel merito di come viene esercitata la responsabilità genitoriale o quella giudiziaria. In mezzo, di nuovo, ci sono i bambini. Che hanno diritto a qualcosa di più del tifo da stadio.
Forse il punto non è schierarsi “con i genitori” o “con i giudici”, ma prendere sul serio il criterio che in teoria dovrebbe guidare tutti: il miglior interesse del minore. È un’espressione che rischia di diventare formula astratta, ma qui significa cose molto concrete: poter crescere in un ambiente sicuro, non insalubre; avere accesso alle cure mediche essenziali; non essere privati della relazione con i pari; non essere esposti al clamore mediatico come simboli di una battaglia che non hanno scelto.
In questo senso, l’etica cristiana e quella laica più matura si incontrano: la responsabilità verso i bambini viene prima della coerenza ideologica degli adulti. Non si tratta di punire uno stile di vita “diverso”, ma di chiedersi se quel “diverso” garantisca davvero la loro dignità. Una casa alternativa può essere una risorsa, un luogo di libertà, ma se diventa un posto in cui non arrivano medici, non arriva nessuno in caso di emergenza, nessuno controlla che tutto proceda bene, allora la domanda non è più romantica: è concreta, quasi brutale.
Allo stesso tempo, la vicenda di Palmoli ci ricorda che non possiamo affrontare temi così delicati a colpi di tweet. Servirebbe un confronto serio sul significato di responsabilità genitoriale oggi, sul rapporto tra educazione parentale e sistema scolastico, sui limiti e le potenzialità degli stili di vita off–grid, su come i servizi sociali possano lavorare non come “polizia delle famiglie”, ma come alleati, capaci di costruire percorsi di accompagnamento e non solo di controllo. Forse questo caso potrebbe diventare, se lo volessimo davvero, l’occasione per aprire tavoli di lavoro reali tra giuristi, pedagogisti, assistenti sociali, famiglie che scelgono la vita rurale e istituzioni scolastiche. Non per giudicarsi, ma per capire cosa significa oggi crescere figli in un mondo che oscilla tra iper–controllo e fuga dalla società.
Il caso della “famiglia del bosco” è diventato un totem su cui proiettiamo le nostre paure: quella di uno Stato invasivo, quella di genitori irresponsabili, quella di bambini dimenticati. In realtà, ci chiede una cosa molto più semplice e insieme più difficile: imparare a rimettere al centro i più piccoli, senza usarli come argomento di battaglia, né come simbolo di purezza né come prova d’accusa.
Forse la domanda vera, alla fine, è questa: che cosa significa davvero “proteggere” un bambino? Tenerlo lontano da ogni rischio, anche a costo di strapparlo dal suo mondo? Oppure lavorare perché quel mondo cambi, perché diventi più sicuro senza spezzare i legami che lo fanno sentire amato? Non esiste una risposta facile, ma è l’unica domanda onesta che possiamo fare.
In questa storia non ci sono eroi perfetti né mostri assoluti.
Forse, un giorno, ripensando alla “famiglia del bosco” non ricorderemo solo le polemiche, ma l’occasione che ci ha offerto: quella di tornare a parlare di infanzia come bene comune, di libertà come responsabilità condivisa, di comunità come rete che cura. Se accadrà, allora anche questa ferita – per quanto dolorosa – avrà generato un frammento di luce nel nostro modo di stare insieme.
La domanda che ci resta addosso, in fondo, è semplice e radicale: vogliamo una società che reagisce solo quando il conflitto esplode, o una società che si prende cura prima, che intercetta le solitudini, che accompagna le scelte di vita alternative invece di lasciarle marcire ai margini? La risposta non sta solo in un’aula di tribunale, ma nel modo in cui ciascuno di noi guarda il prossimo “diverso” che incontra sulla propria strada.
Il compito della società, della politica, della Chiesa, del diritto, non è costruire nuovi “nemici pubblici”, ma creare le condizioni perché nessun bambino sia mai lasciato solo: né in un bosco, né in un sistema che lo guarda solo come un caso.
For questo, forse, il vero passo in avanti che possiamo fare come comunità non è decidere da che parte stare, ma cambiare sguardo. Chiederci come costruire servizi che vadano nelle case prima che esplodano i casi, scuole capaci di dialogare con le famiglie che scelgono percorsi diversi, leggi che non arrivino solo quando la frattura è già insanabile. E, sul piano personale, imparare a sospendere per un momento il giudizio facile – sui genitori “strani”, sui magistrati “freddi”, sui servizi “lenti” – per domandarci che responsabilità abbiamo noi, come cittadini, nel creare o nel tollerare contesti in cui una famiglia finisce per vivere letteralmente fuori mappa, lontano da tutto e da tutti.
In questa prospettiva, la “famiglia del bosco” non è solo un caso giudiziario: è una domanda aperta sulla qualità delle nostre relazioni, sul modo in cui uno Stato sa essere insieme garante di diritti e compagno di strada, sulla capacità di una comunità di tenere dentro anche chi sceglie vie non convenzionali senza rinunciare a proteggere chi è più fragile.
@Riproduzione riservata Francesco Mazzarella