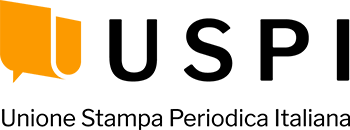La 58ª Marcia Nazionale del 31 dicembre porta in strada parole giuste, volti veri e un tema potentissimo: “La pace sia con tutti voi”. Eppure, proprio mentre camminiamo, resta una domanda scomoda: stiamo costruendo pace o stiamo solo celebrandola?
C’è qualcosa di profondamente umano nel vedere una città camminare. Catania, il 31 dicembre, nel punto esatto dell’anno in cui molti corrono verso il brindisi e l’oblio, sceglie un gesto diverso: mettersi in strada, insieme, con un tema che non chiede applausi ma conversione: “La pace sia con tutti voi: verso una pace disarmata e disarmante”.
Il programma, sulla carta, è persino bello. Bello in modo concreto. Si parte da Piazza Stesicoro alle 15:30, con la musica (quasi a dire che la pace non è solo un concetto ma anche un respiro condiviso). Poi alle 16:00 inizia il cammino, cinque tappe, una dopo l’altra, come una piccola liturgia civile che attraversa simboli, ferite, soglie.
Prima tappa: San Biagio. Saluti istituzionali e una testimonianza in video del Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa: già qui c’è un messaggio implicito, potente e doloroso, perché parlare di pace oggi significa parlare di luoghi dove la pace è diventata una parola che si pronuncia con la gola stretta.
Seconda tappa: il Crocifisso della Buona Morte, con “pace come inclusione sociale”. E qui la pace smette di essere poster e diventa domanda: che pace è, se qualcuno resta indietro, invisibile, escluso?
Terza tappa: Piazza Cutelli, Moschea della Misericordia. Dialogo interreligioso, voce dell’imam di Catania, e la presenza di Living Peace: un passaggio che, in un tempo di polarizzazioni, vale più di cento comunicati stampa.
Quarta tappa: Porto. “Porti aperti alle persone e chiusi alle armi”, con Antonio Mazzeo. È uno di quei punti in cui la pace smette di essere spiritualismo e diventa politica nel senso più nobile: scelta di campo per la vita.
Quinta tappa: Piazza San Francesco. Educazione disarmante, Danilo Dolci e don Pino Puglisi: la pace come grammatica quotidiana, come pedagogia del cuore, non come slogan.
Arrivo a San Benedetto alle 20:40, Messa alle 21:00 presieduta da mons. Luigi Renna, con diretta TV2000.
Fin qui, verrebbe da dire: cosa vuoi di più? È tutto giusto. È tutto pulito. È tutto “a tema”. Eppure, proprio qui nasce il problema. Perché oggi il mondo è pieno di cose giuste che non toccano più nessuno. È pieno di iniziative ineccepibili che però non guariscono. È pieno di parole perfette che rimbalzano su cuori stanchi, disillusi, o semplicemente arrabbiati.
Allora la domanda non è se la Marcia sia bella. Lo è. La domanda è più crudele: è vera fino in fondo? È una risposta reale ai cuori in cerca di pace, o rischia di restare un evento “per chi già crede nella pace”, una conferma per i convinti, un rito rassicurante che non entra davvero nelle zone dove l’odio cresce?
Perché diciamolo senza ipocrisie: viviamo un tempo in cui la pace è diventata un brand. O peggio: una bandierina. C’è chi la usa come clava morale (“io sono per la pace, quindi tu sei contro”), c’è chi la indossa come distintivo identitario (“la pace è la nostra causa”), c’è chi la riduce a cornice emotiva da social. E mentre ci dividiamo su come pronunciarla, la pace vera – quella che costa – resta lì, fuori dalle nostre liturgie, a bussare.
In una visione di Chiesa sinodale, questa contraddizione pesa il doppio. Perché “sinodale” non è una parola gentile: è una postura. È camminare insieme davvero, ascoltare davvero, discernere davvero, lasciare che la realtà ti scompagini, non solo che ti confermi.
E se la sinodalità è ascolto reciproco, allora un evento sulla pace dovrebbe nascere già con un respiro largo, non come “pace dei cristiani”, ma come pace per tutti e, soprattutto, con tutti.
Qui qualcuno obietterà: ma c’è la tappa alla Moschea, c’è il dialogo interreligioso. Vero, ed è un segno importante.
Però non basta inserire una tappa per essere davvero aperti. L’apertura non è un segmento del percorso: è il modo in cui lo costruisci, lo comunichi, lo abiti. È chi parla, ma anche chi decide. È chi è invitato, ma anche chi si sente legittimato a esserci senza doversi travestire da “ospite tollerato”.
Ecco il punto: quando un evento nasce dentro una struttura (ecclesiale, associativa, istituzionale), rischia di portarsi dietro un difetto che conosciamo bene: la pace come “tema”, non come “processo”. Un pomeriggio di parole, cinque tappe, una Messa, un ristoro. Bello. Ma poi? Il 2 gennaio cosa succede? La pace rientra nei cassetti fino al prossimo appuntamento?
Nel frattempo, la polarizzazione continua il suo lavoro sporco. Aumenta l’aggressività nei commenti, la cultura del nemico, il gusto di umiliare l’altro, la tentazione di ridurre ogni persona a una posizione (“sei pro”, “sei contro”). E soprattutto cresce un fatto invisibile: la guerra dentro casa. Coppie che non sanno più parlarsi. Famiglie che vivono sotto lo stesso tetto come estranei. Comunità dove ci si “saluta” ma non ci si incontra. Gruppi dove la pace è proclamata, ma le relazioni sono fredde, funzionali, gerarchiche, a volte feroci nel non detto.
Allora sì: la Marcia è necessaria. Ma non è sufficiente.
E qui entra in gioco la frase che fa da filo conduttore: “verso una pace disarmata e disarmante”. Il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2026 riprende proprio questa prospettiva: disarmare e lasciarsi disarmare, non solo nei conflitti tra Stati, ma nelle logiche profonde che alimentano la violenza.
La CEI, nella Nota pastorale sull’educazione alla pace, insiste sul rischio di una cultura che normalizza la violenza e sulla necessità di formare coscienze e relazioni capaci di riconciliazione.
E allora diciamolo con una provocazione che, se non brucia un po’, non serve: la pace non è una marcia.
La marcia è, al massimo, una soglia.
La pace è disarmare il cuore quando vorresti vincere una discussione. È scegliere parole che non umiliano. È rinunciare alla vendetta piccola quotidiana. È smontare quella droga sottile che è avere ragione. È guardare l’altro e riconoscere che, prima delle idee, c’è un volto.
E se questo non entra nell’evento, l’evento rischia di diventare un contenitore perfetto, ma vuoto. Un “format” della pace. Un gesto che produce emozione ma non trasformazione.
Attenzione: non sto dicendo che sia così. Sto dicendo che può diventarlo, se non facciamo un passo in più. E quel passo, oggi, è tutto.
Quale? Uno soltanto, ma spietato: smettere di pensare che la pace sia un argomento e accettare che è una conversione relazionale. Che costa. Che ti espone. Che ti mette in discussione. Che ti obbliga a non scegliere la scorciatoia della fazione.
E qui Catania, paradossalmente, ha un’opportunità enorme. Perché il percorso stesso contiene semi preziosi: inclusione sociale, dialogo interreligioso, porto e armi, educazione.
Sono parole-chiave che possono diventare un laboratorio, se si trasformano in azioni permanenti. Un patto cittadino: scuola, quartieri, comunità religiose, associazioni, istituzioni, media locali. Non per fare “un altro evento”, ma per creare abitudini nuove.
Immagina se la Marcia non finisse a San Benedetto, ma iniziasse davvero lì. Se il giorno dopo partisse un percorso in tre mosse semplici e verificabili:
un tavolo stabile interreligioso e laico sul linguaggio dell’odio (non sui massimi sistemi, ma su ciò che avvelena le strade e i social);
un presidio educativo nelle scuole su conflitto e riconciliazione (non teoria: pratiche);
una campagna cittadina “porti chiusi alle armi” che si traduca in pressione culturale e politica, con dati, trasparenza, scelte.
Perché oggi la pace non ha bisogno solo di “testimonianze”. Ha bisogno di strutture di cura.
E qui arriva l’altra provocazione, quella che fa male anche a chi organizza con buona fede: se la pace resta percepita come “iniziativa cattolica”, perdiamo metà della città ancora prima di partire. Non perché la città sia contro la pace, ma perché molti non sopportano più la sensazione che ogni bene debba avere un proprietario.
Una Chiesa sinodale – davvero sinodale – non teme questa critica. La abita. La ascolta. E risponde non difendendosi, ma aprendo. Perché la pace non è proprietà di nessuno. È un bene fragile, comune, che ci supera. E se la Chiesa vuole essere segno, allora il segno più potente è questo: non occupare la pace, ma servirla.
La Marcia del 31 dicembre può essere un segno meraviglioso, soprattutto in un tempo in cui l’odio è diventato comodo e la violenza “normale”. Può essere un gesto educativo, quasi ostinato: “noi non ci rassegniamo”.
Ma perché diventi risposta ai cuori, deve compiere un salto: passare dal simbolo al processo, dall’evento alla relazione, dalla bandiera alla cura.
E forse la domanda finale, quella più vera, non riguarda Catania ma ognuno di noi: io, oggi, dove sto alimentando guerra? Nel modo in cui parlo? Nel modo in cui etichetto? Nel modo in cui escludo? Nel modo in cui “ho ragione”?
Se la Marcia ci porta lì, allora è già pace che nasce. Se invece ci lascia soltanto la foto, il percorso, la diretta TV, e poi ognuno torna a casa con la propria piccola guerra domestica intatta… allora sì, sarà stata bella. Ma non sarà stata abbastanza.
Eppure io ci credo: proprio perché non è abbastanza, proprio perché è incompleta, proprio perché è umana, questa Marcia può diventare un inizio vero. A patto che qualcuno abbia il coraggio di dire, ad alta voce e senza accusare nessuno: camminiamo, sì. Ma poi restiamo. Restiamo dentro la fatica della pace. Restiamo a disarmarci.
@Riproduzione riservata Francesco Mazzarella