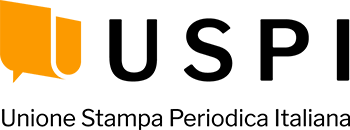Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta della “Congrega degli arguti”, le statue parlanti nascoste nel centro di Roma, utilizzate sin dal XVI sec. come “bacheca” per quella che potremmo chiamare la messaggistica, diciamo pure il twitter ante litteram dei Romani.
Dopo aver visitato virtualmente la più loquace delle sei, il celeberrimo Pasquino, che ha dato il nome ai motti, le famose pasquinate, scopriamo la sua “spalla”, ovvero il cosiddetto Marforio, nel cortile del Palazzo Nuovo ai Musei Capitolini. Databile fra fine repubblica e inizio impero, rappresenta probabilmente Oceano semisdraiato su un letto di rocce che si specchia nell’acqua della vasca, tenendo una conchiglia in mano.
Statua cosiddetta del Marforio, Musei Capitolini, Roma
La statua è stata rinvenuta nel XVI sec. nel forodi Augusto e deve il nome al tempio di Marte Ultore, dinanzi al quale venne alla luce, “Mar-Foro” secondo la corruzione popolare. Era nota come “spalla” di Pasquino, con il quale ingaggiava veri e propri botta e risposta suproblemi sociali e politici, il più famoso dei quali in occasione delle razzie di tesori perpetrate da Napoleone a Roma:
“È vero che i Francesi sono tutti ladri?”
a cui Pasquino rispose:
“Tutti no, ma Bona Parte”
Scendendo dal Campidoglio, nella vicina piazza San Marco, troviamo seminascosto un mezzo busto di donna, la cosiddetta Madama Lucrezia, in realtà raffigurante la dea Iside o forse una sacerdotessa, proveniente dal vicino Serapeum, il tempio dedicato al culto di divinità egizie nei pressi del Collegio Romano.
Statua cosiddetta della Madama Lucrezia, Roma
Il nome popolare le deriva da quello dell’amante del re di Napoli Alfonso V d’ Aragona, Lucrezia d’Alagno, che nel 1457 si recò dal Papa per chiedere la concessione del divorzio per il suo amato, che però le fu rifiutata. Alla morte del re, il figlio Ferrante la cacciò da Napoli costringendola a vivere nel palazzetto adiacente alla statua, che in occasione del primo maggio, durante la festa del “Ballo dei Guitti”, veniva vestita e adornata come una vera dama
Statua cosiddetta del Facchino, Roma
Poco distante, lungo via del Corso, su via Lata, troviamo, addossata al muro di un palazzo, lastatua parlante del Facchino, una fontana risalentealla seconda metà del XVI sec., opera di JacopinoDel Conte come ornamento della sua abitazione in via del Corso, o, secondo un’altra interpretazione, commissionatagli dallaCorporazione degli Acquaroli, cioè coloro che di notte raccoglievano l’acqua dalle fontane pubbliche per rivenderla di giorno porta a porta.Detta in antico il barile o mezzo barile, le sue fattezze, secondo alcuni, sarebbero quelle di un famoso facchino citato in una lapide un tempo collocata a ridosso della fontana, oggi rimossa, che recitava: “Portò quanto peso volle, visse quanto poté ma un giorno nel portare un barile in spalla ne morì”. Secondo altri, invece, per via del berretto e dell’abbigliamento ricorderebbero Martin Lutero, che nel 1511 soggiornò nel vicino monastero degli Agostiniani, motivo per cui il viso veniva preso a sassate dai passanti, risultando oggi quasi del tutto sfigurato.
Statua cosiddetta del Babuino, Roma
Spostandoci lungo via del Babuino, troviamo lastatua parlante soprannominata dal popolo romano proprio Er Babuino poiché a causa della sua bruttezza, vi ravvisava la figura di una scimmia. Tale denominazione divenne ben presto talmente popolare da determinare il cambiamento del nome della strada che era stata aperta da papa Clemente VII e in suo onore chiamata via Clementina.
Realizzata verso il 1576, in origine era costituita da una vasca di epoca romana in granito grigio sulla cui cannella era collocata una statua antica, ma con testa non pertinente, a grandezza naturale in tufo scolpito raffigurante un Sileno disteso su una scogliera. Nel 1877, a causa dei lavori per la costruzione della rete fognaria, la fontana fu smembrata, ma nel 1957, il Babuino fu ricomposto a furor di popolo, nei pressi della suasede originaria, benché sul lato opposto della strada, a sinistra della chiesa di Sant’Atanasio dei Greci.
Statua cosiddetta dell’abate Luigi, Roma
Infine, l’ultima delle statue parlanti, sicuramente la meno nota, si trova su un lato della Chiesa di Sant’Andrea della Valle, la cosiddetta Abate Luigi, così chiamata a causa della presunta somiglianza con il sagrestano della vicina chiesa del Sudario. La statua, che probabilmente raffigura un console o un senatore romano, fu rinvenuta nelle fondamenta di Palazzo Vidoni alla fine del XVI sec e, nel corso dei secoli è stata più volte decapitata per vandalismo, per cui la testa è stata frutto di continue sostituzioni, fino all’ennesima decapitazione avvenuta nel 1966, quando la statua ha parlato per l’ultima volta:
O tu che m’arubbasti la capoccia, vedi d’ariportalla immantinente, sinnò, vòi véde? come fusse gnente me manneno ar Governo.
E ciò me scoccia.