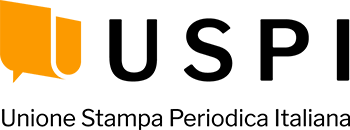In un’epoca che misura il valore delle parole attraverso l’impatto algoritmico, la figura di Gesù ci ricorda che la vera comunicazione nasce dall’incontro e restituisce dignità
Viviamo in un tempo in cui la comunicazione sembra aver smarrito la sua origine più semplice: essere uno spazio di incontro. Ogni giorno veniamo travolti da un flusso continuo di parole, immagini, micro-contenuti, commenti e reazioni che parlano alla mente ma raramente al cuore. La comunicazione, nell’epoca dei social e della visibilità misurata in secondi, è diventata un palcoscenico dove ciò che conta non è la relazione, ma l’impatto. Non la verità, ma la risonanza. Non la profondità, ma l’immediatezza. Tutto deve essere veloce, persuasivo, attraente. E nel tentativo di dare senso a ciò che viviamo, a volte arriviamo a leggere persino il Vangelo con questa lente distorta, trasformando Gesù in un “influencer ante litteram”, un uomo capace di attirare folle e creare movimento come farebbe un creatore di contenuti oggi.
Ma questa interpretazione, per quanto possa sembrare intuitiva, tradisce l’essenza stessa della sua vita. Gesù non ha mai tentato di costruire un pubblico: ha cercato persone. Non ha mai cercato visibilità: ha cercato verità. Non ha mai voluto generare consenso: ha voluto generare libertà interiore. La sua comunicazione non era uno strumento di potere, ma un atto di amore radicale. E l’amore, lo sappiamo, non influenza: trasforma.
Per comprendere davvero la portata di questa differenza, dobbiamo partire da una domanda semplice: che cos’è un influencer? È qualcuno che parla per orientare il comportamento degli altri. Un comunicatore che cerca reazioni, che misura il valore del proprio messaggio dal numero di visualizzazioni, dal tasso di coinvolgimento, dal consenso ottenuto. La comunicazione dell’influencer è quasi sempre unidirezionale: io parlo, tu ascolti; io mostro, tu reagisci; io appaio, tu mi segui. È una comunicazione costruita affinché l’altro si muova verso di me.
La comunicazione di Gesù è l’esatto opposto. Lui non chiede alle persone di seguirlo per aumentare il proprio impatto: chiede alle persone di ritrovare sé stesse. La sua parola non spinge verso di sé, ma spinge verso l’interiorità. Non orienta alla dipendenza, ma alla libertà. È una comunicazione che nasce dall’ascolto, non dal desiderio di essere ascoltati. È un dialogo che inizia sempre dalla fragilità dell’altro, mai dal bisogno di confermare la propria identità.
Basta guardare come incontra le persone. Gesù non organizza eventi, non costruisce scenografie, non cerca la folla. Cammina nei luoghi della vita quotidiana: pozzi, case, strade, barche di pescatori, colline aperte al vento. Non sceglie i potenti, ma gli invisibili. Non cerca chi può fare da cassa di risonanza, ma chi ha bisogno di essere visto. E ogni persona che incontra riceve un linguaggio diverso, un ritmo diverso, un tono diverso. Perché la comunicazione autentica non ripete: accoglie. Non standardizza: ascolta. Non impone: accompagna.
L’incontro con Zaccheo è uno degli esempi più forti. Zaccheo non è un uomo amato, né rispettato. È un esattore, percepito come complice del potere romano. Sta su un albero, lontano, convinto di non meritare uno sguardo diretto. Gesù non lo ignora e non lo rimprovera. Lo chiama per nome. Entra in casa sua. Si espone al giudizio del pubblico senza preoccuparsi della reazione. È un gesto che oggi sarebbe considerato un errore di immagine, un suicidio mediatico. Ma Gesù non comunica per piacere alla folla: comunica per restituire dignità. E Zaccheo cambia non perché subisce un discorso potente, ma perché si sente finalmente visto davvero.
Anche la samaritana vive un incontro che oggi potremmo definire “antivirale”. Nessuno è presente. Non c’è pubblico, non c’è strategia, non c’è narrazione da costruire. Quel dialogo avviene nell’ora più invisibile del giorno, quando la donna va al pozzo per non incrociare nessuno. Gesù non la giudica, non la imbarazza, non la mette in difficoltà. Le restituisce una parola che non pesa ma sostiene. Non cerca di convincerla: cerca di liberarla da ciò che la imprigiona. È un dialogo che vive di autenticità, non di strategia.
E poi ci sono le parabole. Oggi siamo abituati a contenuti veloci, semplificati, pensati per essere condivisi. La parabola è l’opposto: richiede tempo, silenzio, maturazione. Non offre una risposta, offre una domanda. Non impone un’interpretazione, apre una strada. È un metodo narrativo che rispetta la libertà dell’altro e riconosce che nessuna verità può essere compresa se non viene accolta liberamente. Per questo le parabole continuano a parlare ancora oggi: non seducono, ma risvegliano.
Uno dei tratti più rivoluzionari della comunicazione di Gesù è la vulnerabilità. Chi costruisce un’immagine deve proteggerla. Chi cerca consenso deve evitare il fallimento. Chi vuole essere seguito deve piacere. Gesù invece non difende mai la propria immagine. Accetta il rifiuto, la solitudine, il fraintendimento. Non fugge dai momenti di crisi, ma li abita. Non edifica la propria credibilità attraverso il successo, ma attraverso la coerenza. È una comunicazione che non teme di essere ferita, perché non nasce dall’ego ma dalla verità.
Questa differenza è fondamentale oggi, perché viviamo in una società che confonde la visibilità con il significato. Confondiamo rumore con impatto, velocità con profondità, viralità con valore. Ma Gesù ci ricorda che la comunicazione autentica non nasce dal bisogno di apparire: nasce dal desiderio di incontrare. E quando l’incontro è vero, cambia tutto. Perché l’incontro genera relazione, e la relazione genera vita.
Eppure, la nostra epoca non è solo frenesia digitale: è anche un tempo affamato di autenticità. Si percepisce una stanchezza crescente verso messaggi costruiti, contenuti artificiosi, emozioni a comando. Molti giovani dichiarano di non fidarsi più delle piattaforme, dei leader, dei formatori che parlano dall’alto di un palco, e cercano invece voci capaci di stare accanto. È una sete di presenza, non di prestazione. Ed è proprio qui che il modo di comunicare di Gesù diventa sovversivo e attuale: non mette distanza, riduce le barriere, trasforma la vulnerabilità in ponte.
Ogni volta che parla, Gesù non punta a convincere ma a suscitare consapevolezza. Non vuole produrre dipendenza, ma libertà. Non mira alla perfezione apparente, ma alla sincerità. E in questo suo modo di stare, c’è una lezione urgente per la nostra epoca, in cui tanti si sentono invisibili pur parlando continuamente, e in cui tanti si sentono soli pur essendo circondati da voci. Gesù ci mostra che la comunicazione autentica non nasce dalla quantità, ma dalla qualità della presenza.
In ogni incontro mette al centro la persona, non il ruolo. È capace di fermarsi per un malato, per un bambino, per una donna considerata impura, per un uomo rifiutato dalla società. Nel suo sguardo non c’è selezione, non c’è target, non c’è algoritmo: c’è dignità. E la dignità non si comunica, si riconosce. Una comunicazione così è disarmata, ma proprio per questo è indistruttibile. Non può essere manipolata, perché non cerca ritorno. Non può essere comprata, perché non cerca vantaggio. Non può essere imitata, perché nasce da una coerenza interiore che non ha bisogno di dimostrazioni pubbliche.
Gesù entra nelle storie senza giudicare e senza pretendere. Non usa le fragilità altrui per accrescere la propria reputazione; al contrario, le accoglie come terreno fertile. Una comunicazione così non cerca la luce dei riflettori, ma quella che accende dentro. E proprio per questo, chi lo ascolta non si sente spettatore, ma protagonista della propria rinascita.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di recuperare questo stile. La nostra società è piena di parole che feriscono e poche che guariscono. Piena di messaggi che catturano e pochi che liberano. Piena di contenuti che cercano pubblico e pochi che cercano persone. Se applicassimo alla comunicazione quotidiana anche solo una parte del suo sguardo – lo sguardo che non giudica, che non usa, che non strumentalizza – scopriremmo una forma nuova di connessione capace di ricostruire ciò che si è rotto: fiducia, ascolto, reciprocità.
Ed è qui che la comunicazione diventa un cammino. Ogni parola può essere costruzione o demolizione, apertura o chiusura, cura o ferita. E Gesù ci insegna che la parola che costruisce è sempre quella che si avvicina, mai quella che domina. La parola che libera è quella che lascia spazio all’altro; la parola che guarisce è quella che non teme il silenzio.
In un tempo che misura tutto in numeri, Lui ci ricorda che il valore della parola si misura in incontri. In un tempo che confonde la forza con il volume, Lui ci ricorda che la verità è spesso silenziosa. In un tempo che premia la performance, Lui ci mostra che la trasformazione nasce dalla delicatezza.
E allora, forse, il nostro compito è questo: comunicare per costruire, non per convincere. Comunicare per incontrare, non per apparire. Comunicare per amare, non per influenzare. Perché l’abbraccio – quello vero, quello che accoglie senza chiedere nulla in cambio – resta ancora oggi più potente di qualunque algoritmo.
@Riproduzione riservata Francesco Mazzarella