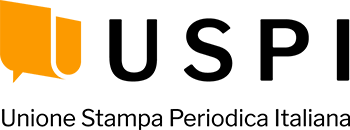Il rifiuto del Vaticano di entrare nel “Board of Peace” non è uno scontro personale: è una scelta di metodo, di diritto internazionale e di responsabilità morale
Il rifiuto non è un “no” a una persona. È un “no” a un’idea di pace che rischia di diventare un marchio, una cabina di regia, una scorciatoia. E quando la Santa Sede dice no, raramente lo fa per impulso: lo fa per indicare un confine, per ricordare che esistono regole, luoghi, responsabilità.
In questi giorni il Vaticano ha comunicato che non parteciperà al “Board of Peace” voluto da Donald Trump: un organismo presentato dalla Casa Bianca come piattaforma per gestire la ricostruzione di Gaza e, progressivamente, altri dossier internazionali. La frase che ha pesato più di tutte è arrivata dalla voce che di solito parla quando la Chiesa decide di stare dentro la storia senza farsi assorbire dalla politica: il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato. Il punto, in sostanza, è questo: le crisi globali si affrontano nel quadro del multilateralismo, e il riferimento resta l’ONU. Il resto, per il Vaticano, “lascia perplessi”.
La notizia è diventata immediatamente un caso mediatico, perché tocca almeno tre nervi scoperti del nostro tempo: la guerra come cronica normalità, la diplomazia che si trasforma in marketing, e la tentazione – sempre più diffusa – di sostituire le istituzioni con piattaforme costruite attorno al potere di turno. Il rifiuto del Papa, letto così, non è una chiusura: è un avviso. È la richiesta, quasi ostinata, di non chiamare “pace” ciò che è soltanto gestione del dopo, se prima non si affronta la radice del conflitto.
Per capire la portata di questo “no” bisogna guardare bene cosa sia, oggi, questo Board. Secondo quanto riportano diverse fonti internazionali, l’iniziativa nasce come un tavolo politico-diplomatico guidato dagli Stati Uniti, con un’agenda che nella sua prima riunione a Washington ruota attorno a un piano di ricostruzione e a un pacchetto di impegni finanziari. Trump lo ha presentato anche come alternativa o correttivo al sistema ONU, in continuità con una linea già nota di diffidenza verso le Nazioni Unite. In quelle ore, tra annunci e promesse, si parla di miliardi, di governance, di forze di stabilizzazione, di piani urbanistici. In altre parole: del “dopo”.
Ma la pace non è il “dopo” messo in ordine. La pace, quando è vera, è un processo in cui la giustizia smette di essere una parola decorativa. E qui il Vaticano vede il rischio: che un organismo nato con logiche politiche, e guidato da un singolo leader, finisca per diventare un luogo di legittimazione più che di composizione. Non basta mettere insieme 20 punti, una cifra tonda di miliardi, un video promozionale, e chiamarlo pace. Il Papa, in questo senso, non “rifiuta Trump”: rifiuta l’idea che la pace possa essere amministrata come un brand, con un comitato di amministrazione e una regia centralizzata.
È qui che la diplomazia vaticana mostra la sua grammatica: parlare poco, ma posizionare bene le parole. “Non partecipiamo” significa: non ci prestiamo. Non mettiamo la firma, non entriamo in un dispositivo che potrebbe essere interpretato come endorsement. Perché il Vaticano, quando entra, lo fa sapendo che ogni presenza diventa simbolo. E un simbolo, nel mondo polarizzato di oggi, viene immediatamente arruolato.
Dall’altra parte, la reazione americana è stata tutt’altro che neutra. In Italia, Euronews riporta le parole della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, che ha definito la decisione vaticana “deeply unfortunate”, molto spiacevole, mentre a Washington la prima giornata del Board vedeva l’Italia presente in forma di osservatore con il ministro Antonio Tajani. Un passaggio che rivela quanto la vicenda sia diventata, rapidamente, anche un tema di equilibri interni europei e di posizionamenti dei governi.
Tajani, infatti, ha difeso la partecipazione italiana come osservatore, sostenendo che “non si può disertare la discussione” e ribadendo che Gaza tocca la sicurezza nazionale. Lo ha fatto in Parlamento, lo ha ribadito nelle ore successive, e l’ANSA riporta anche la sua necessità di respingere l’accusa di “inginocchiarsi” agli Stati Uniti. In mezzo, l’Italia prova a tenere insieme due fedeltà: la relazione atlantica e la sensibilità vaticana. Ma non sempre le due cose coincidono, e questo episodio lo mostra in modo quasi didascalico.
Ora, la domanda che molti si fanno è: perché proprio adesso un “no” così netto? Perché proprio su questo tema? La risposta non sta solo nella geopolitica, ma anche nella visione della Chiesa sul diritto internazionale. Proprio mentre il Board nasceva, Papa Leone XIV – nell’omelia del Mercoledì delle Ceneri – ha usato un’immagine durissima: la guerra che riduce il diritto internazionale “in cenere”. È una frase che non è decorazione liturgica: è la fotografia di un mondo in cui le regole vengono consumate da interessi, vendette, alleanze variabili. In un simile contesto, il Vaticano teme che ogni struttura “alternativa” finisca per accelerare l’erosione delle regole comuni.
C’è anche un altro livello: quello morale. Reuters e altre testate ricordano come Leone XIV sia stato critico verso alcune politiche di Trump, in particolare sul tema migratorio, e come abbia scelto gesti simbolici forti legati alle rotte del dolore: Lampedusa, frontiere, periferie. Non è un dettaglio: perché quando un Papa parla di migrazioni, parla di carne viva, non di statistiche. E quel punto di vista non è facilmente compatibile con l’idea di una pace “gestita” come pratica di potere.
Il rifiuto, allora, diventa una linea: la Santa Sede non rifiuta la mediazione, rifiuta l’impostazione. Non rifiuta l’idea di ricostruire, rifiuta che la ricostruzione venga usata per scavalcare la questione del diritto e della rappresentanza. E qui entra una delle critiche più pesanti che circolano attorno al Board: il rischio di lasciare ai margini i palestinesi stessi, trasformando Gaza in un progetto senza voce. Anche fonti critiche evidenziano la fragilità di una pace pensata senza chi la subisce.
Non è un caso che diversi Paesi europei abbiano scelto distanza o profilo basso. Reuters racconta la sorpresa francese per la presenza della Commissione europea come osservatrice e la decisione di Parigi di non partecipare, almeno finché l’iniziativa non si riallinea alle cornici ONU. Il messaggio è chiaro: l’Europa teme una diplomazia “privata”, un dispositivo che, pur chiamandosi pace, potrebbe ridefinire le gerarchie internazionali senza mandato.
E poi c’è il paradosso che svela l’anima politica dell’operazione: il Board nasce, almeno in parte, come alternativa all’ONU, ma per funzionare ha bisogno di legittimazioni e presenze simboliche. E il Vaticano, da secoli, è una delle più potenti legittimazioni morali del pianeta. Un Papa seduto a quel tavolo avrebbe comunicato al mondo: “questa strada è credibile”. Il “no” comunica l’opposto: “questa strada, così com’è, non basta”.
C’è chi liquida tutto come una schermaglia tra poteri. Sarebbe un errore. Perché qui si gioca un tema più grande: la differenza tra pace e gestione. La gestione è necessaria, certo. Dopo le bombe, dopo i morti, dopo la fame, serve ricostruire. Ma se la pace diventa soltanto la foto del cantiere, rischia di essere una forma elegante di rimozione. La Chiesa, con tutte le sue contraddizioni storiche, in questo caso richiama un principio che oggi appare quasi rivoluzionario: la pace non può essere imposta dall’alto, né comprata con assegni, né gestita come piattaforma. La pace è riconoscimento reciproco, è diritto, è dignità, è responsabilità condivisa.
E qui entra anche un tema che spesso sfugge: la differenza tra “presenza” e “partecipazione”. L’Italia, come osservatore, prova a tenere un piede dentro e uno fuori: ascoltare, capire, non rompere i canali con Washington, ma neppure mettere una firma che poi diventa vincolo politico. Il Vaticano invece sceglie l’opposto: sta dentro il mondo, ma non dentro quel dispositivo. E lo fa sapendo che, proprio grazie alla sua assenza, costringe tutti a fare i conti con una domanda scomoda: può un organismo nato da una presidenza sostituire – anche solo di fatto – la lenta fatica delle istituzioni multilaterali?
La risposta, per la Santa Sede, è implicita. Non perché l’ONU sia “buona” e il Board “cattivo”, ma perché le regole contano più delle intenzioni. Se apri la strada a strutture parallele, domani altri leader faranno lo stesso: board di pace, board di sicurezza, board di ricostruzione. Ognuno con la propria agenda, ognuno con i propri “amici”, ognuno con il proprio linguaggio. E a quel punto il diritto internazionale non si frantuma in un colpo solo: si sbriciola, pezzo dopo pezzo, fino a diventare un ricordo.
Per questo il caso non è soltanto “Trump contro Papa”. È un tema di architettura del mondo. È il modo in cui si decide chi può convocare, chi può guidare, chi può certificare. Reuters racconta che alla riunione del Board partecipano decine di Paesi, con livelli diversi di rappresentanza. Alcuni mandano leader, altri ministri, altri ambasciatori, altri ancora osservatori. Questa geometria variabile è un indicatore: molte capitali vogliono esserci senza esporsi, vogliono ascoltare senza farsi arruolare.
E l’Europa, su questo, appare divisa. La Francia si è detta sorpresa dalla presenza della Commissione, perché la Commissione non ha un mandato automatico a “rappresentare” gli Stati membri su un tavolo così sensibile. Il punto non è burocratico: è politico. È la paura che l’Unione, già fragile nelle sue sintesi, finisca per essere trascinata in un format americano senza aver discusso e deciso davvero.
Questa frattura è importante, perché Gaza non è soltanto un luogo: è una ferita morale dell’Occidente. Ogni volta che si parla di ricostruzione si parla anche di responsabilità. Chi paga? Chi decide? Chi garantisce? Chi controlla? Chi rappresenta i palestinesi? Chi parla per i bambini, per gli sfollati, per chi non ha più una casa? E soprattutto: chi mette un limite alla logica del “dopo” se il “prima” non viene mai nominato fino in fondo?
Il Vaticano, con la sua scelta, sembra dire: attenzione, perché la ricostruzione non può diventare un modo elegante per evitare la parola “giustizia”. Nel lessico diplomatico, la giustizia è spesso la parola più temuta, perché obbliga a nominare colpe, responsabilità, violazioni. Eppure senza giustizia non c’è pace, c’è solo amministrazione di un equilibrio precario. È qui che la posizione vaticana, al di là delle simpatie e antipatie, assume un valore pedagogico: ricorda che la pace non è un prodotto da consegnare, ma un cammino da garantire.
Qualcuno potrebbe obiettare: ma il Vaticano stesso, nella storia, è stato parte di equilibri e compromessi. Vero. E proprio per questo, quando decide di non partecipare, lo fa sapendo quanto sia facile cadere nella trappola del “male minore”. Qui la trappola sarebbe la più seducente: sedersi al tavolo, dire “noi ci siamo”, sperare di “orientare” dall’interno. Ma orientare dall’interno, spesso, significa essere usati dall’esterno. Il Vaticano sceglie di non prestarsi, e paga il prezzo di essere criticato da chi preferirebbe un Papa “collaborativo” a prescindere.
C’è poi un aspetto quasi spirituale, che però ha conseguenze concrete: la Chiesa non può predicare la pace come conversione del cuore e nello stesso tempo legittimare un modello di pace che somiglia a una gestione geopolitica. Non perché la geopolitica sia sporca, ma perché ha una logica diversa. La fede parla di riconciliazione, la politica spesso parla di deterrenza. La fede parla di perdono, la politica parla di interessi. Tenere insieme questi due livelli è delicato, e proprio per questo il Papa, quando entra, entra con un rigore che ai più appare incomprensibile.
Ecco perché, in controluce, il rifiuto diventa un invito: tornare a una pace che non scavalchi i popoli. Una pace che non riduca le vittime a numeri. Una pace che non trasformi i territori in “progetti”. Una pace che non si faccia fotografare solo nei palazzi, ma che passi per le strade, per gli ospedali, per le scuole, per le famiglie spezzate. È un invito che riguarda anche noi: quando commentiamo questi fatti, stiamo davvero difendendo la pace o stiamo soltanto scegliendo una tifoseria?
In un’epoca di comunicazione istantanea, il rischio è credere che la pace si faccia a colpi di dichiarazioni. In realtà la pace è un lavoro di pazienza: ascolto, negoziato, garanzie, monitoraggi, tribunali, corridoi umanitari, ricostruzioni trasparenti, lotta alla corruzione, riconoscimento politico. Sono parole meno “vendibili”, ma sono le uniche che reggono nel tempo. Se il Board di Trump vorrà davvero essere credibile, dovrà misurarsi con questa sostanza, non con il rumore della sua inaugurazione.
E qui si apre una possibilità che vale la pena custodire: il “no” del Vaticano può costringere il Board a maturare. Può spingerlo a cercare una cornice ONU, a includere più voci, a chiarire mandato, trasparenza, limiti. Può diventare un contrappeso, un freno utile, una domanda che impedisce l’autocelebrazione. In questo senso, il rifiuto non è distruzione: è discernimento.
Perché la pace, alla fine, non è una bandiera da sventolare. È una responsabilità da portare. E ogni responsabilità vera chiede anche il coraggio di dire: “così no”. Non per opporsi, ma per proteggere. Non per dividere, ma per impedire che la parola “pace” venga svuotata.
Se c’è una luce da tenere accesa in questa storia, è questa: la diplomazia, quando è autentica, non serve a vincere. Serve a salvare. Salvare vite, salvare futuro, salvare un pezzo di umanità possibile. E forse il Papa, con questo rifiuto, ci sta ricordando proprio questo: che la pace non è l’evento di Washington, non è il comunicato stampa, non è la cifra in miliardi. La pace è la scelta quotidiana di non ridurre l’altro a nemico, e di costruire istituzioni che reggano anche quando i leader cambiano.
Nel mondo “in fiamme” di cui ha parlato Leone XIV, la vera notizia non è che il Vaticano ha detto no a Trump. La vera notizia è che qualcuno, ancora, prova a difendere l’idea che esista un bene comune globale, una grammatica condivisa, una casa fragile chiamata diritto internazionale. Non è perfetta. Ma è l’unica che abbiamo. E se vogliamo che non diventi cenere, dobbiamo smettere di cercare scorciatoie e ricominciare a pretendere processi.
@Riproduzione riservata Francesco Mazzarella