Piazza Navona e la cupola di Sant’Agnese in Agone, splendido scenario dell’incontro con l’autore, avvocato, Segretario Generale di USPI Unione Stampa Periodica Italiana e docente di Editoria Periodica alla Sapienza Università di Roma. Nel volume Francesco Saverio Vetere narra di una notte di Capodanno attraversato da ricordi dialoganti tra sette amici insieme a rievocare vicende lontane …
Roma – Nella splendida cornice di Piazza Navona, sotto la cupola di Sant’Agnese in Agone -meravigliosa opera architettonica ad opera di Borromini-, il 23 luglio scorso si è tenuta la  presentazione del libro “Le luci della strada”, ultima opera pubblicata del Prof. Avv. Francesco Saverio Vetere, Segretario Generale USPI.
presentazione del libro “Le luci della strada”, ultima opera pubblicata del Prof. Avv. Francesco Saverio Vetere, Segretario Generale USPI.
Il libro racconta di ”sette amici sulla sessantina che si incontrano la notte di capodanno nella casa dell’unico non sposato e parlano per tutta la notte, a modo loro, di fatti lontani nel tempo” è stato pubblicato poche settimane fa da Edizioni Efesto che ha curato, in collaborazione con l’Associazione Brutium e la sua Presidente, Gemma Gesualdi, l’organizzazione della presentazione.
Durante l’evento sono intervenuti il Dott. Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Asl Roma 4 e Commissario straordinario Asl Roma 3, la Prof. Maria Panetta, Docente di mediazione culturale e cultura letteraria presso l’Università di Roma “Sapienza”, Pino Strabioli, Conduttore televisivo RAI, e Alfredo Catalfo, titolare della Casa Editrice Efesto ed editore del libro.
Il libro è reperibile online (Ibs.it, Amazon, sul sito di EdizioniEfesto nella collana theoretikà, ecc.)
………………………………………………………..
Nei giorni scorsi, inoltre, su Diacritica, bimestrale indipendente fondato da Maria Panetta e Matteo Maria Quintilianila, è stata pubblicata la recensione del testo (che potrete trovare qui di seguito), proprio ad opera della docente di Mediazione culturale e cultura letteraria della Sapienza di Roma.
“RECENSIONE DI FRANCESCO SAVERIO VETERE, “LE LUCI DELLA STRADA”
di Maria Panetta
La vita non è una serie di lampioncini disposti in bella simmetria: la vita è un alone luminoso, un velo diafano che ci avvolge dall’origine della coscienza sino al suo limite. Non è forse compito del romanziere comunicare questo variabile, sconosciuto e illimitato spirito, in qualunque via di aberrazione e di complessità si svolga, con la minima confusione di elementi eterogenei?
 È con queste riflessioni di Virginia Woolf, tratte dal suo saggio sul Romanzo moderno, apparso, in traduzione, in Italia nel 1934 su «Occidente», che ritengo utile accostarmi all’opera che segna l’esordio letterario come romanziere di Francesco Saverio Vetere, avvocato, Segretario Generale dell’Unione Stampa Periodica Italiana nonché docente di Editoria Periodica alla Sapienza Università di Roma.
È con queste riflessioni di Virginia Woolf, tratte dal suo saggio sul Romanzo moderno, apparso, in traduzione, in Italia nel 1934 su «Occidente», che ritengo utile accostarmi all’opera che segna l’esordio letterario come romanziere di Francesco Saverio Vetere, avvocato, Segretario Generale dell’Unione Stampa Periodica Italiana nonché docente di Editoria Periodica alla Sapienza Università di Roma.
Quando mi ha rivelato, mesi fa, che aveva messo utilmente a frutto il tempo lungo del periodo del lockdown per dedicarsi alla scrittura creativa, confesso di non essere rimasta particolarmente sorpresa, conoscendolo come persona curiosa della vita e del mondo, e piena di interessi. Ho considerato, poi, un privilegio poter leggere in anteprima le pagine dell’opera uscita, in seguito, nel giugno scorso, e non mi sono affatto stupita del fatto che avesse trovato subito un editore per il proprio romanzo: al riguardo, mi fa piacere sottolineare l’accurata veste grafica che Edizioni Efesto ha saputo dare al volumetto, corredandolo di un’indovinata immagine di copertina, che, come i suoi lettori ben sanno, non costituisce un abbellimento casuale, ma, assieme al titolo cui rimanda, si rivela un elemento paratestuale utilissimo a captare il “sugo” della storia, come direbbe Manzoni.
Dopo una raccolta di poesie e un racconto, intitolato La storia, Vetere approda, dunque, alla narrazione romanzesca, che, nel suo caso, s’intesse di svariati elementi teatrali, tanto è vero che, a mio avviso, questo romanzo potrebbe essere fruttuosamente utilizzato anche per trarne una sceneggiatura per un’opera cinematografica: il primo elemento squisitamente “teatrale” è la prevalenza dei dialoghi, per cui l’opera può essere quasi definita un esempio di narrazione corale, cui contribuisce ciascuno dei sette amici sulla sessantina che si radunano, la notte di Capodanno, a casa del solo non sposato, e trascorrono le ore tentando di ricostruire una vicenda che ha come protagonisti principali Guido Grimaldi e Rosy Tabacco, ma che li vede partecipare tutti come attori apparentemente secondari.
La scelta della notte di Capodanno implica la sottolineatura di un momento liminare di passaggio, di una soglia temporale che distingue un “prima” da un “poi”: infatti, i sette (numero, peraltro, denso d’implicazioni filosofiche) usciranno dalla conversazione cambiati, perché più consapevoli sia di una storia che riguarda un loro caro amico nonché maestro, sia di se stessi.
Leggendo le pagine delle Luci della strada, ci si ritrova immersi in un’atmosfera che, anche se non direttamente, richiama alla memoria alcune opere capitali della letteratura italiana e mondiale, fra le quali, ad esempio, il Decameron: e forse non è un caso che la fase di scrittura del romanzo abbia coinciso con un momento di reclusione in spazi angusti, che ci ha fatto sentire tutti idealmente vicini alla condizione psicologica dei dieci giovani della brigata dei novellatori, in fuga da Firenze per salvarsi dalla pestilenza, sebbene essi si fossero intelligentemente rifugiati in campagna, e dunque non al chiuso. In ogni caso, quello di Gabriele, la voce narrante principale, almeno nella Parte primadel libro, ricorda un po’ il ruolo delle sette regine o dei tre re delle dieci giornate in Boccaccio, essendo affidato a lui il compito di ricostruire una storia letta in un libro letteralmente andato in fumo e, in seguito, quello di richiamare all’ordine gli altri compagni, sempre vivacemente a rischio di perdersi in briose divagazioni ed esuberanti battute di spirito.
Un altro espediente letterario della tradizione viene, dunque, in soccorso a Vetere, l’idea – appunto – del manoscritto ritrovato alla Manzoni o alla Potocki, ma nel suo caso le cose si complicano, perché il manoscritto (anzi, il dattiloscritto) di autore ignoto (in realtà, nelle pagine finali, sembra di capire chi possa averlo steso, ma Vetere accortamente non lo rivela), rinvenuto da Gabriele in un baule di casa (e il pensiero corre inevitabilmente al riordino che tutti abbiamo condotto di soffitte e mansarde e armadi durante il periodo della reclusione forzata) e “divorato” dal primo narratore, finisce misteriosamente nel fuoco accanto al quale Gabriele lo aveva letto fino alla fine. Fuoco che – si capirà – rappresenta una metafora («i fogli li ha bruciati il fuoco fisico. Noi dobbiamo accenderne un altro, non fisico», precisa una delle voci a p. 18), anche perché le circostanze della dissoluzione materiale del dattiloscritto sono alquanto improbabili e sembrano aprire, nella mente dei sette amici, quasi l’ipotesi di un intervento soprannaturale, collegato all’improvviso spalancarsi di una finestra che Gabriele ricordava chiusa (p. 17). Sulla definizione del genere cui apparteneva il testo letto da Gabriele nel dattiloscritto resta un margine di ambiguità: forse un romanzo, meglio «una storia» (p. 15), «come dei ricordi» (p. 16); di certo, non «un diario» (ibidem).
Il secondo elemento di teatralità è rappresentato da quella sorta di didascalia che introduce la Parte prima del testo, intitolata Il libro; il terzo, almeno nella suddetta prima parte del romanzo, consiste nell’ambientazione al chiuso, che può ricordare certe atmosfere degli Indifferenti di Moravia, ma che ha evocato alla mia memoria soprattutto le amate pagine delle Menzogne della notte di Bufalino. Un’immagine quasi pittorica, poi, da cenacolo (anche filosofico) è quella che fotografa il momento della spiegazione che Gabriele fornisce ai sodali riguardo alla perdita del dattiloscritto: «Istintivamente tutti gli si avvicinarono ancora di più. Erano seduti a semicerchio vicino al fuoco e sembravano un corpo unico. Gabriele era esattamente al centro» (p. 17).
Quest’idea del “corpo unico” viene sottolineata anche dalla frequente impossibilità di ricostruire chi stia effettivamente parlando, fra i sette amici: ma l’ambiguità è voluta e cercata dall’autore, a sottolineare la forza del legame che unisce i compagni di strada, che, pur caratterizzati da individualità ben delineate, sono accomunati da un’infanzia vissuta assieme e da alcuni adulti di riferimento, fra i quali spiccano i due protagonisti principali della storia raccontata e ricostruita, Guido e Rosy, sorta di ideali “fratelli maggiori” e maestri (specie nel caso di Guido).
Il titolo del dattiloscritto, Metafisica dell’Amore, sembra mettere al centro dell’indagine proprio la citata coppia, ma, in realtà, la protagonista del romanzo si può dire sia la Filosofia, e in particolare l’arte della maieutica e il procedimento del dialogo filosofico. La delicata ed emozionante ricostruzione dell’intensa storia d’amore fra Guido e Rosy, apparentemente finita nel momento della loro separazione fisica, ma, in realtà, durata tutta la vita per il tramite della scrittura, si rivela, forse, solamente un pretesto per ricompattare il gruppo degli amici cresciuti assieme e per ricordare loro, a quarantaquattro anni dalla sua partenza per l’estero, gli insegnamenti del fuoriclasse Guido, geniale studioso di filosofia approdato a un’università scozzese forse anche grazie all’intermediazione di chi lo amava di un amore generoso e sincero, e riteneva di dovergli fornire delle ali, più che tenerlo legato a sé tramite vischiosi lacciuòli.
Guido è il protagonista indiscusso del Prologo: interessante, infatti, è anche la costruzione del romanzo, che procede alternando lunghi dialoghi a flashback e sortite nel “mondo esterno”. Il cuore del testo, però, consiste proprio nella sorta di Simposio al quale partecipano i sette amici, interrompendo a tratti la loro ricostruzione di ricordi comuni con salame, pane, vino rosso, caciocavallo, caffè; sigarette, sigari, tabacco. Anche loro sono seduti intorno al fuoco, e la citazione dell’immagine del «fuoco che balza» (p. 13 e sgg.) rimanda alla nota Settima lettera di Platone, vero fulcro filosofico del testo e insegnamento fondamentale di Rosy (professoressa di Lettere e «donna bella, forte», p. 52) al geniale Guido e, di conseguenza, a tutti i suoi adepti. Non a caso, uno dei brindisi viene dedicato proprio «a Rosy Tabacco, la Signora del nostro cuore» (p. 21).
Suggestiva è anche la ricostruzione della vita delle cittadine evocate (Normanna, Sanseverino), centri di un Sud d’Italia dal tempo sospeso, oltre alle descrizioni fisiche e psicologiche, in pochi tratti puliti, dei notabili del luogo, con i loro nomi altisonanti (Altavilla, Sanseverino, Grimaldi etc.), a rievocare una società nobiliare dal sapore antico e i suoi alti valori cavallereschi. Ma eguale spazio viene dedicato anche alle famiglie più umili – ma dignitose («in generale, le persone mantenevano un atteggiamento dignitoso. […] Credevano in qualcosa»: p. 26) – alle quali appartengono alcuni dei protagonisti, accomunati da una parabola esistenziale di riscatto da una condizione di indigenza o di sudditanza culturale, forse proprio grazie all’allenamento all’uso della ragione cui li aveva indirizzati Guido («Ragionamento semplice e sottoporre a verifica tutto quello che si dice. Pensare con la propria testa, ma seriamente, con rigore»: p. 67), con la sua capacità di divulgazione e di semplificazione di concetti complessi, senza scadere nella banalizzazione (grande dote che, da sempre, non caratterizza
tutti gli accademici). Qualche frecciata contro il mondo universitario si legge, fra le righe, allorché, ad esempio, si parla di «quelli che facevano gli autisti ai professori e pubblicavano scopiazzature di tesi» (p. 72); o quando si commenta: «In realtà facevano di tutto perché il merito non fosse un criterio per la carriera universitaria» (p. 70). Ma le punzecchiature presenti nel libro sono sempre vergate da una mano leggera e in tono ironico.
Le digressioni filosofiche del romanzo sono state ben intrecciate col procedere della vicenda e si amalgamano fluidamente all’interno dei dialoghi fra gli amici, senza mai appesantirli. Non a caso, a mio avviso, a chiusura della prima parte del testo si cita il Nietzsche dell’assunto: «La verità è la più grande menzogna che l’umanità abbia mai inventato» (p. 83); gli stessi adepti al cenacolo, infatti, si rendono conto del fatto che non è tanto importante ricostruire effettivamente come andarono i fatti fra Guido e Rosy, perché l’accertamento della Verità, semmai fosse possibile, è meno significativo del cammino che si percorre insieme sulla strada che vi conduce. E assai interessanti, a latere, sono anche le riflessioni sulla contrapposizione fra “realtà”, «Bella parola, utile. Sottovalutata» (p. 87), e «culto della verità» (ibidem).
La seconda parte del romanzo, infatti, s’intitola L’immaginazione, e mette in campo una facoltà diversa da quella razionale, ma egualmente fondamentale; più esplicito è anche il riferimento alla già citata Settima lettera di Platone, cui Guido approda dopo aver studiato e dopo essersi confrontato con «tutto quello che era stato scritto nella storia della filosofia» (p. 102), e poi con «ermetismo, gnosticismo, sufismo, filosofie orientali» (p. 103).
La Settima lettera di Platone, straordinario testo epistolare attribuito al filosofo e scritto in prima persona, allude alla «dottrina segreta, non scritta» (ibidem), sulla quale «nessuno avrebbe trovato nulla e che faceva sì che il pensiero di Platone, quello profondo, non fosse conoscibile leggendo le sue opere» (p. 106), perché la sua “scienza” non era comunicabile: «come fiamma s’accende da fuoco che balza: nasce d’improvviso nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni sull’argomento e una vita vissuta in comune, e poi si nutre di se medesima» (p. 107). Un insegnamento di vita, questo, che promuove un’affascinante concezione della conoscenza come “scintilla” e valorizza a tal fine la condivisione delle esperienze e lo scambio comunicativo; e uno spunto di riflessione preziosissimo, specie in tempi come questi, di “distanziamento fisico” e di potenziamento della didattica a distanza.
«Se metto per iscritto un qualunque risultato, questo sarà travisato, perché sarà visto non come una tappa di un percorso infinito, ma come una pretesa di verità. Con un doppio errore, quindi» (p. 110): ecco una formulazione semplice ed efficace della battaglia combattuta da alcuni pensatori contro qualunque sistema filosofico rigido, che abbia la pretesa di essere definitivo e il cui autore non sia disposto a sentirsi “superare” dai suoi successori. E, al riguardo, non può non venirmi in mente uno dei miei auctores, Benedetto Croce.
Come ha recentemente sottolineato Giancristiano Desiderio nel suo ultimo lavoro sul pensatore abruzzese di adozione napoletana, «la vera filosofia, come la vera poesia, è tutta occasionale ossia nasce dalle necessità della vita»[1]: tale osservazione si adatta alla perfezione anche a questo libro, nato proprio intorno a un nucleo ben definito, esattamente come i romanzi di Camilleri, che s’irradiano attorno a un episodio, «per cerchi concentrici, centripeti»[2]:
Aveva aperto gli occhi. Lo spiazzo era circondato dal buio e nel buio Pietro e Franz continuavano a guardarlo. Stava pensando, ragionando dentro di sé. Era sempre quella esigenza di capire, di dare un senso a tutto.
E vedeva solo ciò che era illuminato. Due parti non lo erano: tutto ciò che andava oltre la portata della luce e tutto ciò che stava dentro di lui.
Era sempre stato così, finché non aveva saputo che doveva cercare dove non c’era luce. Ma lì non c’era ordine, né senso. Né tempo né figura.
Era stata lei a dirglielo. Allora doveva essere vero per forza (p. 131).
Ecco il “sugo” della storia.
Platone, Aristotele, Plotino, il grande Rumi affiorano fra le pagine di un romanzo “misto”, intessuto di filosofia. Ma Vetere, grande appassionato della disciplina, dimostra, con questa nuova opera narrativa, di non disconoscere il valore insostituibile della letteratura amena, se persino Guido, indiscusso genio filosofico, approda felicemente alla scrittura romanzesca per restare per sempre in contatto, attraverso il messaggero segreto e silenzioso della lettura, con il suo grande Amore.
La terza parte del romanzo s’intitola Il segreto: un segreto fatto di buio, di luce e di ambigui chiaroscuri. Ma, come ogni segreto che si rispetti, non può essere rivelato; e la scrittura di Vetere sa condurre felicemente in porto la narrazione, lasciando aperti svariati interrogativi e ammantando di brulicante silenzio il mistero della vita e della morte”.
 tutti gli accademici). Qualche frecciata contro il mondo
tutti gli accademici). Qualche frecciata contro il mondo
il mondo universitario si legge, fra le righe, allorché, ad esempio, si parla di «quelli che facevano gli autisti ai professori e pubblicavano scopiazzature di tesi» (p. 72); o quando si commenta: «In realtà facevano di tutto perché il merito non fosse un criterio per la carriera universitaria» (p. 70). Ma le punzecchiature presenti nel libro sono sempre vergate da una mano leggera e in tono ironico.
Le digressioni filosofiche del romanzo sono state ben intrecciate col procedere della vicenda e si amalgamano fluidamente all’interno dei dialoghi fra gli amici, senza mai appesantirli. Non a caso, a mio avviso, a chiusura della prima parte del testo si cita il Nietzsche dell’assunto: «La verità è la più grande menzogna che l’umanità abbia mai inventato» (p. 83); gli stessi adepti al cenacolo, infatti, si rendono conto del fatto che non è tanto importante ricostruire effettivamente come andarono i fatti fra Guido e Rosy, perché l’accertamento della Verità, semmai fosse possibile, è meno significativo del cammino che si percorre insieme sulla strada che vi conduce. E assai interessanti, a latere, sono anche le riflessioni sulla contrapposizione fra “realtà”, «Bella parola, utile. Sottovalutata» (p. 87), e «culto della verità» (ibidem).
La seconda parte del romanzo, infatti, s’intitola L’immaginazione, e mette in campo una facoltà diversa da quella razionale, ma egualmente fondamentale; più esplicito è anche il riferimento alla già citata Settima lettera di Platone, cui Guido approda dopo aver studiato e dopo essersi confrontato con «tutto quello che era stato scritto nella storia della filosofia» (p. 102), e poi con «ermetismo, gnosticismo, sufismo, filosofie orientali» (p. 103).
La Settima lettera di Platone, straordinario testo epistolare attribuito al filosofo e scritto in prima persona, allude alla «dottrina segreta, non scritta» (ibidem), sulla quale «nessuno avrebbe trovato nulla e che faceva sì che il pensiero di Platone, quello profondo, non fosse conoscibile leggendo le sue opere» (p. 106), perché la sua “scienza” non era comunicabile: «come fiamma s’accende da fuoco che balza: nasce d’improvviso nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni sull’argomento e una vita vissuta in comune, e poi si nutre di se medesima» (p. 107). Un insegnamento di vita, questo, che promuove un’affascinante concezione della conoscenza come “scintilla” e valorizza a tal fine la condivisione delle esperienze e lo scambio comunicativo; e uno spunto di riflessione preziosissimo, specie in tempi come questi, di “distanziamento fisico” e di potenziamento della didattica a distanza.
«Se metto per iscritto un qualunque risultato, questo sarà travisato, perché sarà visto non come una tappa di un percorso infinito, ma come una pretesa di verità. Con un doppio errore, quindi» (p. 110): ecco una formulazione semplice ed efficace della battaglia combattuta da alcuni pensatori contro qualunque sistema filosofico rigido, che abbia la pretesa di essere definitivo e il cui autore non sia disposto a sentirsi “superare” dai suoi successori. E, al riguardo, non può non venirmi in mente uno dei miei auctores, Benedetto Croce.
Come ha recentemente sottolineato Giancristiano Desiderio nel suo ultimo lavoro sul pensatore abruzzese di adozione napoletana, «la vera filosofia, come la vera poesia, è tutta occasionale ossia nasce dalle necessità della vita»[1]: tale osservazione si adatta alla perfezione anche a questo libro, nato proprio intorno a un nucleo ben definito, esattamente come i romanzi di Camilleri, che s’irradiano attorno a un episodio, «per cerchi concentrici, centripeti»[2]:
Aveva aperto gli occhi. Lo spiazzo era circondato dal buio e nel buio Pietro e Franz continuavano a guardarlo. Stava pensando, ragionando dentro di sé. Era sempre quella esigenza di capire, di dare un senso a tutto.
E vedeva solo ciò che era illuminato. Due parti non lo erano: tutto ciò che andava oltre la portata della luce e tutto ciò che stava dentro di lui.
Era sempre stato così, finché non aveva saputo che doveva cercare dove non c’era luce. Ma lì non c’era ordine, né senso. Né tempo né figura.
Era stata lei a dirglielo. Allora doveva essere vero per forza (p. 131).
Ecco il “sugo” della storia.
Platone, Aristotele, Plotino, il grande Rumi affiorano fra le pagine di un romanzo “misto”, intessuto di filosofia. Ma Vetere, grande appassionato della disciplina, dimostra, con questa nuova opera narrativa, di non disconoscere il valore insostituibile della letteratura amena, se persino Guido, indiscusso genio filosofico, approda felicemente alla scrittura romanzesca per restare per sempre in contatto, attraverso il messaggero segreto e silenzioso della lettura, con il suo grande Amore.
La terza parte del romanzo s’intitola Il segreto: un segreto fatto di buio, di luce e di ambigui chiaroscuri. Ma, come ogni segreto che si rispetti, non può essere rivelato; e la scrittura di Vetere sa condurre felicemente in porto la narrazione, lasciando aperti svariati interrogativi e ammantando di brulicante silenzio il mistero della vita e della morte”.
 Da sinistra: Giuseppe Quintavalle, Pino Strabioli, Francesco Saverio Vetere
Da sinistra: Giuseppe Quintavalle, Pino Strabioli, Francesco Saverio Vetere -

Da sinistra: Alfredo Catalfo, Francesco Saverio Vetere, Gemma Gesualdi, Alessandro Astorino

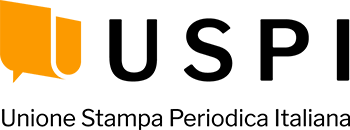

 Da sinistra: Giuseppe Quintavalle, Pino Strabioli, Francesco Saverio Vetere
Da sinistra: Giuseppe Quintavalle, Pino Strabioli, Francesco Saverio Vetere 